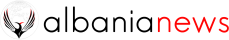Fuori c’era un vento forte. Papà girava per casa preoccupato, non parlava. Poi spense le luci e andò a dormire, invitando anche me a farlo. Avevamo i letti freddi ma al sicuro. Un mondo che profumava di famiglia, protetta da mani forti e piene d’amore di mio padre e mia madre. Quella notte c’è stata una bufera.
Da tempo sentivamo notizie in arrivo da Tirana, di studenti universitari che avevano occupato le aule. Il primo pensiero, ovviamente, è stato di paura, per le conseguenze che ci sarebbero potute essere. Anche a Durazzo per due giorni la tensione era stata altissima, per la guerra ormai iniziata. Si temeva il peggio. La rivolta degli studenti aveva chiamato la popolazione alla protesta dandole la forza di riunirsi tutti in piazza a Durazzo.
Ricordo che il boulevard era barricato dai soldati che avevano il compito far mantenere l’ordine. Ma quest’ultimi erano più spaventati di noi. L’ordine a loro dato era di sparare sui manifestanti in caso di aggressione. Ho visto un gruppo di manifestanti assalire il palazzo del Comune, tentando di sfondare l’entrata principale, un attacco respinto dai militari. Alcuni di loro furono presi con forza per essere messi sui furgoni della polizia e portati via. Ritornai a casa molto spaventata. I miei mi proibirono di uscire per non mettermi nei guai.
Erano giorni tristi. I negozi erano quasi tutti chiusi. Eravamo semplicemente “vittime” di una dittatura, che nulla ha a che fare con ‘l’ideale comunista’. Giorni dopo si sentì che alcuni avevano assalito le ambasciate a Tirana barricandosi all’interno.
Tempo dopo sentimmo che in tanti avevano preso le navi per raggiungere l’Italia. Finalmente anche papà decise che dovevamo farlo anche noi. E così partimmo. Indossavo un paio di scarpe blu, un pantalone blu e un maglione rosa. Avevo 19 anni. Dimenticai la mia giacca, per la fretta di scappare.
Tenevo stretta mia sorella più piccola, di appena 14 anni, e mentre correvo tenevo stretta la mano di mio padre. Nell’aria si sentiva un forte odore di polvere da sparo. Ci indirizziamo verso il porto di Durazzo, dove trovammo, prima dell’entrata, mia sorella grande, al sesto mese di gravidanza in compagnia di suo marito.
Papà aveva avvertito anche loro. Tentammo l’entrata al porto, blindato da soldati che avevano l’ordine di sparare su chiunque avesse tentato di oltrepassare il cancello. Ricordo le mani di mio padre, gonfie dalla fatica, perché aveva lavorato tutto il giorno. Mise la mano in tasca e poi la distese verso il militare, al quale disse che quelli erano gli unici soldi rimasti.
Mi chiese di lasciargli la mano e di non avere paura, volgendo il viso verso il soldato come se gli volesse chiedere di non sparare; il soldato mise il fucile in giù e ci face passare.
Provavo sentimenti contrastanti, paura di lasciare casa, paura di non vedere più la mamma e mio fratello che erano rimasti nascosti, ma nello stesso tempo immaginavo un futuro diverso, pieno di speranza. Non stavo lasciando soltanto il mio mondo, ma i miei affetti, con cui ho vissuto e condiviso la sofferenza, la disperazione, la persecuzione, le gioie e i dolori.
Il viaggio verso la libertà, il più lungo della mia vita, fatto di lacrime di gioia e di dolore. Vivevo quei momenti con la certezza che, una volta arrivati in Italia, avrei acquistato la libertà che sognavo ma a un prezzo caro. Avevo lasciato due persone importanti della mia vita. Pensavo: meglio morire una sola volta che tutti i giorni sotto dittatura.
Quel giorno era arrivato, pioveva e faceva freddo, tanto. Mio padre mi prestò la sua giacca. Papà mi disse da esperto, che il mare era di forza cinque e che saremmo arrivati in ritardo perché il peschereccio non poteva affrontare quelle onde troppo forti. Sì, perché era un rottame senza bussola (i militari avevano avuto l’ordine di toglierle a tutte), il regime aveva previsto la fuga di massa.
Trentasei lunghissime ore sotto la pioggia e il freddo e in balia delle onde, tra la vita e la morte. Arrivammo all’alba, ma le nuvole ostacolavano la visibilità. Riuscimmo a vedere il porto di Brindisi, verso le ore dieci. Non provavo più paura. Volevo che qualcuno mi aiutasse, e che aiutasse tutti noi.
Ci accolsero le forze dell’ordine. Chiesi a papà come mai ci fosse la polizia armata, mi rispose dicendo che anche loro hanno paura di noi. Ci fecero scendere dopo tre ore. Oramai i vestiti si erano asciugati sul nostro corpo stanco. I poliziotti ci tiravano dai vestiti. Trattenni le lacrime, ma la mia faccia piangeva per me. Nessuno mi ha mai umiliata così. Da quel momento mi si formò un nodo alla gola. Non avevo più lacrime, penso di averle lasciate tutte lungo il mare.
Avevamo i volti stanchi e gli occhi rossi dalla salsedine. La strada da lì in poi è stata in salita, fatta di solitudine interiore, mancanze, nostalgia di casa, così come di fatica per il lavoro, di umiliazioni e di digiuno. Sì, perché una notte a digiuno non pesa quanto l’umiliazione di un proprietario di casa che urla perché non hai pagato l’affitto nel giorno prestabilito. Il Paese che doveva darmi la speranza mi toglie il sonno, il sorriso e la libertà, raggruppata in quel pezzo di carta chiamato “permesso di soggiorno”. Mi fa provare la fame, mi fa perdere la sicurezza, mi ruba il sonno. Quel nodo alla gola diventava sempre più grande.
Il mio volto oggi svela i drammi di estenuanti viaggi di sofferenza dentro di me. Trovo conforto soltanto attraverso il pensiero, vivendo con la speranza che un giorno tutto cambierà. È così è stato. La vita mi ha concesso un po’ di pace, quella speranza che avevo conservato gelosamente dentro di me. Grazie a tutti i miei amici italiani, che continuano a conservare gelosamente la nostra bellissima amicizia.
Diana Doci