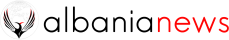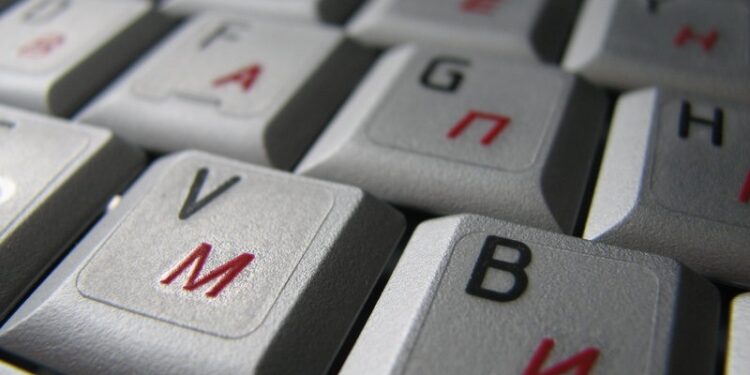Una riflessione di Sonila Alushi sugli alunni e studenti nati da genitori non italiani in Italia, che prende spunto da un’esperienza personale successale qualche giorno fa.
I termini “straniero”, “extracomunitario”
Sarebbe utile riflettere e discutere più spesso sui termini “straniero” ed “extracomunitario” utilizzati nei confronti di bambini che nascono in questo paese o sono arrivati in tenera età. Appartengono a loro queste espressioni emblematiche e stigmatizzate di una provenienza che vivono poco e conoscono per lo più dalla narrazione degli adulti?
Ad esempio, i miei bambini sono nati qui in Italia, qui vivono, vanno all’asilo e l’unico luogo che chiamano casa è il nostro piccolo appartamento nella città di Bergamo dove con mio marito viviamo da 12 anni. Pur essendo molto attenti nell’insegnarli la nostra lingua madre e molte delle nostre usanze e tradizioni, chi può biasimarli se alla domanda “Di dove sei?” rispondono “Di Bergamo”?! Amano fare le vacanze nel nostro Paese d’origine (Albania), incontrare i cuginetti, andare al mare e mangiare bakllava (dolce tradizionale), ma chi spiega loro che questo basta per non chiamarli italiani?!
Trovo veramente inaccettabile il fatto di lasciare in eredità ai nostri figli, queste etichette le quali oltre che essere indicative di uno status che a mio avviso non li appartiene affatto, sono anche cariche di pregiudizi e stereotipi. Infatti, già nelle prime esperienze scolastiche, i bambini nati da genitori non italiani vengono considerati diversi o ancora peggio, un ostacolo per i successi scolastici dei bambini autoctoni! Non penso vi siate dimenticati del polverone che si è alzato due anni fa, grazie alla mozione Cotta sull’istituzione delle classi ponte, oppure le dichiarazioni dell’Assessore alla Scuola del Comune di Roma Laura Marsilio sulla provenienza degli alunni nati da genitori non italiani. Casi che non hanno fatto altro che acuire le paure delle famiglie italiane. Poi, tutti hanno iniziato a discutere appassionatamente della sostenibilità della qualità di insegnamento nelle nostre aule scolastiche con quote superiori al 30 per cento di allievi nati da genitori non italiani.
I processi di polarizzazione in atto già da tempo, hanno avuto il loro momenti di picco in quei freddi mesi d’inverno creando delle conseguenze che definirei veri e propri guai. Si è parlato talmente tanto di rallentamenti e patologia da suggestionare molti genitori italiani, i quali hanno visto come la soluzione migliore del “problema” l’iscrizione dei propri figli in scuole dove la presenza di alunni nati da genitori non italiani è meno sentita. Il primo guaio sta proprio in questa privazione di conoscenza e scambio che gli adulti impongono ai piccoli, senza tenere conto del fatto che la presenza di questi bambini, è un arricchimento che stimola nel mondo scolastico e fuori esso un importante processo di integrazione reciproca. In altre parole, le differenze, le altre lingue, i diversi costumi sono una ricchezza e un vantaggio non solo per chi le possiede, ma anche per chi può conoscerle.
Detto ciò, è altrettanto vero che alcuni dei bambini nati da genitori stranieri incontrano difficoltà nel percorso formativo. È da sfatare la diffusa convinzione che motivo principale di tali disagi, sia un livello di italiano non sufficiente in quanto loro imparano contemporaneamente la lingua d’origine e l’italiano. L’idea che l’utilizzo in casa della lingua madre ostacoli l’apprendimento dell’ italiano, non incontra il consenso degli esperti di Educazione e bilinguismo, anzi i professionisti sostengono il contrario considerando il bilinguismo un vantaggio, poiché la conoscenza di più lingue darà più possibilità di scelta nella vita e anche benefici più sottili, quali l’apertura mentale del bambino nell’accettazione del diverso.
“Il bambino ha bisogno di mantenere le lingue separate, ed è costretto ad impegnarsi in un esercizio continuo per dividerle a posteriori. Se la mamma parla cinese e il papà parla italiano al figlio andrà benissimo, anche se poi la mamma e il papà parlano tra di loro una delle due lingue o addirittura una terza lingua. Tra le conseguenze più comuni di non mantenere le lingue separate c’è la balbuzie. Certo, il bambino bilingue normalmente inizia a parlare un po’ più tardi rispetto ai suoi coetanei, ma il ritardo è solo provvisorio e intorno all’età di quattro o cinque anni, il distacco dai loro coetanei sarà impercettibile” Elisabeth Deshays, “Come favorire il bilinguismo dei bambini” (Edizioni Red, 2003)
Invece Antonio Genovese, Professore presso l’Università di Bologna, dove insegna Pedagogia interculturale in diversi corsi di laurea, interpellato dal portale Bandiera Gialla durante un’inchiesta sulle classi ponte a dicembre di due anni fa , si sofferma sul significato e delle difficoltà che si possono incontrare durante l’apprendimento di una seconda lingua.
“Per un bambino/a straniero che vive nel nostro paese, l’italiano non è una lingua straniera, ma una vera e propria “lingua 2” (L2), cioè una lingua che si affianca a quella materna e lo rende bilingue. Dunque, è una lingua che veicola emozioni, sentimenti, paure, simpatie, antipatie, conflitti, relazioni, e non solo una lingua di informazioni e di regole. Personalmente, ritengo che le difficoltà più grosse siano di tipo relazionale: fare amicizie stabili, partecipare attivamente a gruppi amicali non di soli stranieri, non essere soggetti a sguardi “pesanti” e ad atteggiamenti discriminatori per il colore della propria pelle, per la religione professata, per la cultura di cui si è portatori…” Antonio Genovese
Dall’altra parte, sembra che gli alunni nati da genitori non italiani, non siano il problema principale della qualità di insegnamento. A dirlo è l’insegnante Laura Dondi dell’Istituto Guercino di Bologna, nella stessa inchiesta di Bandiera Gialla: “Non mi è mai capitato che gli alunni stranieri abbiano rallentato la programmazione condivisa dall’intera classe. Alcuni è vero, parlando l’italiano solo a scuola e con i loro coetanei, possiedono un patrimonio lessicale più povero ma questo gap linguistico si colma rapidamente quando iniziano a leggere e scrivere in italiano”.
Se pur avvantaggiati perché dotati di più lingue e mentalità più aperta, gli alunni nati da genitori non italiani, secondo una ricerca della Fondazione “Giovanni Agnelli” del settembre 2010 (I figli dell’immigrazione nella scuola italiana), risulta comunque abbiano risultati meno positivi degli autoctoni: i diplomati agli esami di maturità sono il 95,5%, rispetto al 97,8% degli studenti autoctoni. Gli “italiani” in corso, lungo tutto il ciclo dell’istruzione, sono l’82,6%, gli “stranieri” in corso solo il 55%. Allora ci si chiede: non sarà perché noi migranti viviamo in condizioni sociali e familiari più disagiate?
È quanto vale come incoraggiamento per i nostri figli, il fatto che le prospettive di inserimento professionale riguardano i rami meno prestigiosi del sistema? Non inciderà su tutto ciò anche una diffuso handicap nella pedagogia interculturale ad insegnare in classi multietniche? Quanto conta nella valutazione delle potenzialità di apprendimento degli alunni nati da genitori non italiani, i pregiudizi e gli stereotipi che possono esserci anche tra gli insegnanti? Infine, esiste un dibattito professionale e politico consapevole dei danni per il futuro degli immigrati e il profilo sociale e civile del paese? Se vogliamo definirla proprio patologia, è evidente che la ricetta del 30 percento non solo si è rivelata inefficace, ma anche controproducente.
Conclusione
Siamo in presenza di nuovi scenari sociali, e dobbiamo saper individuare risposte adeguate per rafforzare la qualità del nostro sistema scolastico. Allontanare i nostri figli gli uni dagli altri, porterà solo a un mero adattamento e non allo scambio reciproco che rappresenta la vera integrazione. Non dimentichiamoci che i bambini hanno molto meno pregiudizi degli adulti e sono capaci di crescere insieme indipendentemente dal colore della pelle, della lingua o del modo di vestire.