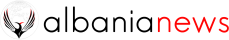Nel 1941 – 1942 la Casa editrice DISTAPTUR di Tirana aveva progettato di pubblicare un libro del grande albanologo Padre Giuseppe Valentini S.
J., che raccogliesse i suoi articoli pubblicati sulla rivista del turismo albanese “DRINI”. Questo è il secondo articolo, Da Tirana al Matja (2a parte).Da Mamuras un sentiero su per le pendici, se volete, vi condurrà a Shmrifa (S. Maria) a 7 km. Dalla strada maestra: era una bella chiesetta a tre navate, lunga venticinque passi a larga dieci nella navata centrale e quattro in ciascuna delle laterali; è ancora in piedi per metà, con vestigie d’affreschi nell’abside: otto vescovi e santi e sette medaglioni di profeti; a fianco su una roccia un resto di campanile in cotto. Ora è una desolata meta di pellegrinaggio tra i secolari cipressi, i soliti indici infallibili di vecchio sagrato cristiano; però ancora, cristiani e mussulmani ci vengono con le loro offerte per la Madonna di Settembre.
Tutto invita a credere che questa fosse la cattedrale della diocesi Arbanense: vero è che più tardi troviamo la residenza di quel vescovo, più al nord nella regione di Kurbini, ma non mancano accenni che faccian credere si tratti ivi d’una sede di fortuna; qui invece siamo in pieno Arbën, in quella interessante regione, cioè, che in modo un po’ misterioso avrebbe dato il nome d’Arbënia (poi Albania) a tutto il Paese.
Procediamo e volgendoci a guardare a sinistra fra le paludi vediamo una delle tante località che ci risuscitano un nome dei più storici d’Albania: Golemja, un feudo dei Golemi, curioso nome dinastico la cui origine si perde nella notte storica del Medio Evo: finché un nuovo Muzaka (e, possibilmente, un po’ più attendibile del vecchio) non si scoprirà perché ci guidi nel dedalo delle origini dinastiche albanesi; non sapremo, se i tanti Golemi che appaiono ex abrupto ad ogni svolta della storia di questa nazione, fossero dei Comneni di nobile origine bizantina o dei Guglielmi (Gulami) di fiera schiatta normanna.
Spingendo lo sguardo più in là e un po’ indietro: una lunga catena di colline corre e degrada sull’orizzonte verso il mare: la montuosa e boscosa ossatura della penisola di Rodoni (Mali Kerçakës-Mali Muzhllit), la quale chiude a sud nel suo amplesso la baia del Drino e del Matja. Era una volta la regione, ricca di conventi e di castellucci feudali, della forte tribù dei Redoni: laggiù fra loro, Skanderbeg, aveva uno dei suoi ricettacoli, non meno utile dell’alta montagna, quando si teneva fuori di Croia per molestare gli assedianti; tra loro, minacciato di tradimento, trovava la più riposante sicurezza, e costruiva il torrione di Qurril; tra loro, dopo la sua morte,alla fine del ‘400 i Veneziani trovarono buona corrispondenza e il figlio di Skanderbeg il suo piede a terra per lo sfortunato tentativo di risorgimento.
Sulla destra invece abbiamo davanti a noi la vasta tribù dei Kurbini, l’unica, forse, di tutte le tribù dell’alta Albania che ci sia nota fin dall’era antica, o almeno l’unica il cui nome incontriamo non troppo alterato negli storici antichi. Difatti, ci racconta Livio, che la piazza forte che si trovava presso i «Caravantini» fu una di quelle che Gentio, re d’Illiria, si studiò d’avere a sua disposizione contro i Romani nel 168 a.
C.; vi mandò suo fratello (che per una curiosa coincidenza si chiamava Caravanzio), ma questi, appunto, qui trovò resistenza, tanto che gli fu impossibile accorrere in aiuto del fratello incalzato a ritirarsi da Lissos (Alessio) e minacciato d’assedio in Scutari, sicché Gentio, credendosi ormai destituito di soccorso, perdette speranza e capitolò.
Ora, osservata di passaggio la finale «ini», che è identica in «Caravantini» e «Kurbini» (come anche in «Scodrini», che era il tribule degli abitanti di Scodra, ora Scutari), abbiamo le due radicali karab (ant) e «kurb» entrambe non accentate: facilmente le due «a» non accentate hanno perduto chiarezza, riducendosi la seconda a una insensibile «e» muta, e la prima ad «u» per effetto della «r» che segue una «e» semimuta, gruppo che – come è noto – facilmente in bocca albanese si sente come «u», con un ultimo facile passaggio da «v» a «b», abbiamo appunto «kurb», come volevasi dimostrare; schematicamente:
K a r a v
K ë r ë v
K u r b
La teoria è del defunto insigne letterato e linguista scutarino D. Andrea Mjedja, e si scuserà se forse sarà riuscita termino logicamente inesatta in bocca a un profano della chimica linguistica: – Procediamo.
Poco più oltre un inconfondibile odore di uova fradice ci avverte che siamo a Zeja e attraversiamo il rigagnolo d’acqua solforosa chiamato appunto l’Acqua Marcia o Fetida /Uji i Qelbët) od anche Uji i Barrdhë), le Aquae Albulae del Barlezio. In questa regione una traduzione erudita del clero cattolico albanese, ben provvista però di fondamento toponomastico locale, pone una antica città di Sebaste, di cui rimangono considerevoli fondazioni sulla cima detta Kalaja Gjytet ( il Castello Cittadella, se pur questo non è il castello dei Caravantini); la stessa tradizione vorrebbe che qui fosse vescovo e subisse il martirio San Biagio, quello tanto invocato contro il mal di gola, e che anche i noti Santi Quaranta Martiri di Sebaste qui abbiano avuto la corona.
Vero è che comunemente la Sebaste di San Biagio e dei Santi Quaranta viene collocata in Armenia, non senza del resto trovare considerevoli difficoltà storiche e geografiche; ma si osserva che da Armenia ad Arbënia (nome di questa regione) lo scambio può non essere stato tanto difficile, tanto più che Armenia era ben più nota: certo qui la topografia – grotta di S.
Biagio, Monte Argeo sovrastante palude ghiacciata (quella formata dalle Acque Fetide sotto la strada), terme (di cui sembra rimangano vestigie) – v resta a capello a tutte le esigenze degli Atti dei Martiri, inoltre la diffusione del culto di San Biagio è qui notevolissima, come si può rilevare dal’uso che si fa di tal nome come nome di persona e come toponimo, nonché dal buon numero di chiese che gli sono dedicate in tutta l’alta Albania fino a Ragusa che l’ebbe patrono ab immemorabili; così pure i Santi Quaranta hanno buoni testimoni d’antico culto a cominciare da qui (poco più oltre sulla via vi è la località Sh’Katraqind, i Santi Quattrocento, per iperbole popolare) fino a Saranda (Agioi Saranda, Santi Quaranta, ora Porto Edda) con la grandiosa basilica ad essi dedicata. Si aggiunga che in tutti questi dintorni, fino a Lac e oltre, si sono rinvenuti numerosi tumuli con abbondanti suppellettili romane accompagnate da monete di Settimio Severo, di Diocleziano e di Massimino Daza.
Si apre ora ai nostri occhi il bel paesuccio medioevale, degno d’un presepio umbro, sparso di dignitose casine simili a castellucci bianchi sulla fosca costa della collina boscosa. Si vede che siamo nella regione classica del feudalismo albano-angioino, la regione di quei baroni albanesi con cui tante trattative intavolava e tanta politica faceva a base di zecchini e di pezze di scarlatto Venezia dagli ultimi tempi dei Topia in poi. Questa – si chiama Gjolmi o Gjonëmi (la «Sylva Jonimorum» del Barlezio) – dev’essere stata o la culla dinastica o almeno uno dei ricettacoli più sicuri di questa forte famiglia di baroni di strada alla normanna, che diedero tanti grattacapi ai rettori veneti col loro lungo altalenare fra Venezia e i suoi nemici o rivali, finché trasferitasi a Scutari, diede agli stabilimenti della Serenissima i più prodi e fidi cavalieri e lasciò il suo nome al barbacane davanti alla porta principale di quel castello.
Sulla sinistra vediamo Fusha e kuqe (la pianura rossa) un altro dei buoni agguati di Skanderbeg fra paludi e canali, e, alla marina, il porticino di Patok, famoso già nel Medio Evo, specialmente come emporio di sale e di derrate, col nome di Suffada e Suffaday (erroneamente Semfadag).
<br
/>Ancora un po’ e siamo a Lac, uno dei veri feudi di Dukagjini (qui probabilmente di quelli del ramo di Perlati). C’è una chiesa medioevale circondata di pretenziose tradizioni: c’è chi la vorrebbe consacrata ai tempi di Skanderbeg, c’è chi si accontenta che la consacrazione sia avvenuta per opera d’un gruppo di vescovi albanesi reduci dal Concilio di Trento. Certo è che il convento dei Francescani vi era già da antica data e fu anzi a lungo noviziato; ora è celebrato santuario di S. Antonio di Padova.
Un po’ più in là, a circa cinque chilometri dalla strada sulla destra, c’è Delbinishti (toponimo di cui si sospetta una parentela con Tumenistus che in Barlezio è il nome del monte che le sovrasta e ora si chiama Mali i Skanderbegut, succeduta, come residenza dei vescovi di Arbëni e poi degli Arcivescovi di Durazzo, a S. Veneranda (Shna Prendja) di Kurbini che si trova più in dentro ancora d’una decina di chilometri, già importante abbazia.
Riconosciuto il terreno, rifacciamoci ora indietro e ricostruiamo alcuni dei principali episodi dell’epopea che si svolse intorno a Croia.
Proprio qui, fra Miloti e Delbinishti dove ormai ci troviamo, venne attirato da Skanderbeg per tutta la valle del Matja l’esercito turco che accompagnava il suo nipote traditore Hamza Castriota nel luglio del 1457. La mattina di quel giorno, come pratico del paese, s’era spinto a saccheggiare la campagna, fino a Suffada (Patok) riportandone, oltre al sale di quell’emporio, un po’ di viveri, i primi che riuscisse a raggranellare per tutta la regione da Dibra in qua, ben ripulita in antecedenza dal provvido Skanderbeg. Fino a quel momento questi non aveva ritenuto opportuno dar segno di vita, giudicando difficile cogliere all’impensata un uomo come Hamza, sveglio di sua natura e cresciuto proprio alla sua scuola. Qui, invece, sempre osservando, di nascosto ma da presso, come soleva, ogni fatto del nemico, dalla montagna vide che la straordinaria scorpacciata, consentita dalla preda del mattino, in quel tropicale meriggio di luglio, tra i grassi vapori della piana, produceva i suoi effetti; qua e là giacevano i corpi dei turchi oppressi dall’afa, dal cibo e dal sonno; sveglie poche guardie e pochi capitani che, raccolti a consiglio con Hamza e col Pascià nella tenda di quest’ultimo, stavano decidendo d’andare a tentare Croia.
Allora il Castriota, lasciato il grosso della sua truppa alle pendici del Monte, con pochi uomini corse a fare un colpo di mano o una finta dalla parte opposta. Alla fuga d’una sentinella dalla guardia sorpresa, che si salvò correndo e gridando per il campo, questo comincia a allarmarsi; Skanderbeg allora comanda l’assalto generale; scende dal monte il grosso dell’esercito, da nord accorre impetuoso e urlando senza posa come suole Mojs Golem Dibra con la cavalleria, da un altro lato Tanusio Topia, Peico Emanuele e Giovanni Stressio con la fanteria e gli archibugieri si fanno sotto; e tutti ben distribuiti d’ogni lato, bene armati d’un numero straordinario di trombe e di tamburi da far credere che un esercito innumerevole di tutta l’Albania e fors’anche di Venezia si fosse raccolto a prendere in mezzo l’armata turca. Inutilmente Hamza badava a gridare ai suoi che egli ben conosceva le poche forze di Skanderbeg e i suoi soliti stratagemmi; inutilmente pagava di persona. Tutto fu travolto nella fuga e nella stage fin giù alle Acque Bianche, le quali, uccisivi i resti degli scampati, avrebbero meritato in quel giorno, dice il Barlezio, il nome di Acque Rosse. Solo il Pascià (probabilmente Ishak Evronos, luogotenente del gran visir Mahmud per il governo di Rumili) riuscì a scampare grazie a quella che, con curioso termine ciceroniano, il Barlezio chiama «pernicitas equi» e noi dovremmo dire, sit venia verbo,«la gambezza del suo cavallo» ossia la velocità del corsiero; Hamza fu fatto prigioniero, e il resto della truppa turca diede gran da fare agli albanesi per seppellirla per questi campi.
Veniamo ora all’assedio di Croia del 1450 sotto Sultan Murat. Il campo turco era posto a semicerchio sotto le pendici, nella pianura fra Micio e Zezë detta allora Tirana Minore. Skanderbeg aveva posto il suo centro operazione sul Monte di Croia (Mali i Krus); non monte di Kranja come dice Fan noli seguendo uno sbaglio di stampa del Barlezio che poi si corregge. Si ha memoria che durante il primo assalto alle mura, Skanderbeg calando dal monte con 5.000 cavalieri scelti invase il campo e ne fece man bassa finché dovette ritirarsi non senza pericolo per la sua vita. Poi lasciando sulla montagna solo un presidio di 500 cavalieri con Tanusio Topia e Mojs Golem Dibra, trasferì il suo campo a Mëndikli, donde a poco meno d’un chilometro poteva più da vicino assillare il nemico: di là nottetempo, appena ebbe sentore che, secondo l’intesa, Dibra calava coi suoi ad allarmare il campo turco da una parte, egli lo assalì, lo devastò e vi fece strage dall’altra, e senza che si osasse inseguirlo, trasportò le sue tende alle pendici boscose del Rodoni verso l’Ishmi dove facilmente, per mare, veniva rifornito di viveri dai Veneziani di Durazzo. Di là fece un altro bel colpo di notte andando a sorprendere il campo nemico dalla parte di Mëndikli; poi ritirandosi, si tirò dietro il grosso della truppa turca, mentre Mojs Golem Dibra entrava dall’altra parte e devastava ogni cosa; trascinato il nemico su per gli erti pendii e fattogli il fiato grosso, appena ebbe un rinforzo, che attendeva, li ricacciò giù a sassate e a frecciate malconcio, si ritirò sulla montagna dove fu visto l’indomani scopertamente ad intendesi con gli assediati. Lassù lo cercarono poco dopo i messi del Sultano con proposte di pace, ma non ve lo trovarono; lo cercarono a Ishmi, ma sempre era irreperibile, finché, fattisi accompagnare da prigionieri albanesi a cui promisero libertà, per mezzo di questi riuscirono a scovarlo a Fusha e Kuqe dove aveva trasportato l’accampamento.
Il Castriota li ascoltò, e, benché rispondesse con fiero rifiuto, li convitò a lauto pranzo, ma però subito partiti i messi, trasferì le sue tende sulla montagna. Di là, avuta notizia d’una malattia del Sultano, dopo due primi assaggi d’incursione nel campo turco, la terza notte prese le mosse dalla pianura di Tirana in direzione sud-nord per dare impeto alla carica della cavalleria per la rasa campagna; ma l’oscurità troppo profonda portata dalle nubi che copersero il cielo, non permisero né agli albanesi di avanzare fin sotto le trincee, né ai turchi allarmati dal calpestio della carica di uscire in piano; allora Skanderbeg con 100 scorridori a cavallo s’avanzò a provocarli, e a forza di punzecchiare riuscì a tirarsene dietro un distaccamento per poi spezzettarlo e ricacciarlo; finalmente, fattosi un po’ di barlume verso mattina, i turchi mandarono un reparto sulle pendici a tagliargli la ritirata verso la montagna dove stava Mojs Golemi di presidio: Skanderbeg, che lo prevedeva aveva già disposto il combattimento su due fronti per poi frantumare i nemici e ricacciarli; i Turchi resistettero quanto poterono, finché, non venendo loro soccorsi, dovettero ritirarsi in disordine riportando gravi danni. Poco dopo venne tolto l’assedio.
Quando nell’agosto del 1466, il Sultano Maometto lasciò all’assedio di Croia Ballaban Pascià, che aveva occupato il sempre minaccioso Mali Krus, Skanderbeg, aiutato dai Veneziani e fornito d’esercito raccogliticcio, preparò un piano d’accerchiamento verso la montagna presidiata dalle milizie di Ballabano; Lede Dukagjini, presumibilmente da Rodoni, e Nicolò Moneta, scutarino, coi veneti e dalmatini da Alessio per il Bosco degli Jonima dovevano assalire contemporaneamente il nemico. Ma ecco che il Castriota riceve notizia della venuta di un altro corpo di spedizione che veniva giù, probabilmente, per la valle del Matja, e s’era attestato sulle Montagne di Bulgeri sulla destra di quel fiume evidentemente per tagliare le comunicazioni con Alessio e Scutari s’era attestato sulle Montagne di Bulgeri più che per congiungersi con il fratello, come pensa il Barlezio, allora, mossosi celermente di notte, scaccia il presidio turco dalla montagna e di là mostra i due prigionieri al Pascià: questi, disperato, ordina un assalto supremo alle mura e rimane ucciso; i resti del suo esercitosi ritirano in rotta verso Tirana e di là riescono ad evadere a fatica.
Salutiamo questa pianura e questi colli dell’Arbën, così ricchi di storia e d’eroismo.
L’articolo di Padre Giuseppe Valentini S.
J. è stato pubblicato nel N. 2 – Anno II di DRINI – Bollettino mensile del Turismo albanese – Tirana, Martedì 1 aprile 1941.
Le fotografie originali provengono dall’Archivio di Franco Tagliarini