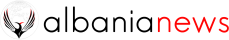Se venisse chiesto ad uno studente italiano quale accezione abbia la parola “bella” nella storia del suo paese, subito uno menzionerebbe la famosa canzone “Bella ciao.”
Forse anche uno studente albanese risponderebbe nella stessa maniera.
Anche tra gli adulti, pochi sanno che “bella”, in albanese è anche il diminutivo di una persona che ha lasciato tracce nella storia degli anni della dittatura di Hoxha.
Precisamente è il nome di una ragazza albanese. Si chiamava Isabela Islami, ma tutti la chiamavano Bela (In albanese non esistono le lettere doppie.)

La storia di Bela, Klement e Zamira
La sua è anche la storia di suo fratello Klement e della sorella Zamira
Erano nella più bella età della giovinezza e vivevano a Tirana.
I loro genitori provenivano da famiglie che avevano subito la persecuzione della dittatura e della lotta di classe.
Con il passare degli anni, le vecchie ferite inferte dalla repressione della polizia di stato sembravano essersi rimarginate, non più sanguinanti. La loro famiglia, come tutte le famiglie albanesi, conduceva una vita modesta: i genitori lavoravano, mentre i figli andavano a scuola. Almeno al liceo, perché per l’università, per problemi biografici, non ne avevano diritto.
La loro odissea ha per protagonista il fratello, Klement.
Nel 1975, lui aveva 19 anni e frequentava gli studi di maturità presso il ginnasio Petro Nini Luarasi di Tirana.
Un giorno di aprile, tra amici, gli venne l’idea “sbagliata” di fare una battuta contro il regime comunista.
Quasi tutti i figli della massima dirigenza del partito e dello stato, chiamati anche i figli del Bllok, (il Blocco), studiavano in quel ginnasio.
Per la vigilanza rivoluzionaria, come si chiamava all’epoca la sorveglianza di tutti contro tutti, era naturale che i ragazzi provenienti dalle famiglie come quella di Klement, fossero tenuti sotto costante sorveglianza.
Klement è stato ammanettato in classe davanti ai suoi compagni.
Durante le indagini, pur essendo un ragazzo, non ha potuto sottrarsi alle torture fisiche e psicologiche. Tuttavia, i giudici, forse vista la sua età o consapevoli di condannare un innocente, ebbero pietà di lui. Klement non fu mandato al campo minerario di Spaç, nel nord dell’Albania, nei confronti del quale, l’inferno di Dante era un paradiso.
Il ragazzo è stato “fortunato”, per tre anni fu rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Elbasan, dove i pazienti venivano sottoposti a torture “scientifiche”. I medici sperimentavano su di loro, delle dosi massicce di sedativi compresa l’elettroterapia chiamata anche l’elettroshock.
Uscito dal manicomio, nel 1978 si unì alla famiglia la quale non viveva più a Tirana. A causa sua, erano stati dichiarati indesiderabili per il regime e internati nel villaggio di Çermë, Lushnje.

Çermë era una specie di gulag, come quelli dei tempi di Stalin nell’Unione Sovietica, dove il regime isolava i suoi oppositori o le persone che creavano problemi politici e sociali. Vivevano in una baracca, lavorando dalla mattina alla sera, per una ricompensa ridicola.
Come gli altri familiari, anche Klement lavorò zappando la terra. Abbassò la testa, sopportò le umiliazioni, gli insulti e le prese in giro dalla parte delle autorità e delle persone che erano fedeli al Partito.
Lo confortava solo il fatto che il loro internamento aveva una durata di 8 anni. Lui e le sue due sorelle erano giovani e sognavano un giorno di tornare a Tirana, dove erano cresciuti e dove avevano parenti e amici.
Finalmente il giorno tanto atteso arrivò: il loro esilio era finito ufficialmente, ma non in realtà.
Loro padre bussò in ogni porta dell’amministrazione locale, ma non ebbero mai il permesso di ritornare a Tirana, con la scusa che non fosse arrivato nessun permesso ufficiale da Tirana.
Furono sconvolti, disperati ma abbassarono la testa e non protestarono più, almeno a parole.
Klement cercò di persuadere le sue due sorelle a fuggire dall’Albania. Dovevano prendere le loro sorti in mano e dirigersi verso la loro libertà.
All’inizio, Bela e Zamira pensavano che una proposta del genere fosse folle. Dove andare, come andare, con che cosa?! Era impossibile scappare dall’Albania, dovevano rassegnarsi al loro destino e sperare che la dittatura finisse prima possibile.
Loro padre anziano, sostenne l’idea. Quanto a lui e alla mamma, più di quello che il regime aveva già fatto loro, non poteva più infierire.
La madre esitò un po’. Lei, per dieci anni, era stata incarcerata come prigioniera politica e temeva che i suoi figli subissero la stessa sorte. Tuttavia, anche lei appoggiò l’idea della fuga.
Fuggire, ma come!? Con che cosa?!?
Dall’Albania ci si poteva fuggire via terra o mare.
Da terra era molto difficile: prima di raggiungere le zone di confine, ci si doveva passare attraverso diversi posti di blocco, dove veniva mostrata la carta d’identità. Agli altri posti di blocco, che distavano circa 20 km dal confine e venivano considerati zona vietata, bisognava esibire un lasciapassare che, con grande difficoltà, veniva rilasciato solo alle persone fidate, dalla Direzione della Polizia distrettuale.
Se, anche questo ostacolo veniva superato, chi voleva fuggire doveva superare con successo anche la “curiosità” dei paesani della zona verso gli estranei. Perché, non appena notavano un nuovo volto che girava nei dintorni, subito gli chiedevano il permesso di attraversare la zona off limits.
Attraversare il confine durante il giorno era fuori discussione, era molto difficile. Di notte lo era di più, perché bisognava orientarsi bene e non perdersi tra le tante montagne che circondano l’Albania.
Un grosso ostacolo era anche il clone, così veniva chiamata una striscia di denso filo spinato, alto più di tre metri. Il clone non si trovava esattamente sulla linea di confine ma, al suo interno, sul suolo albanese. Adiacente al clone, parallelo ad esso, c’era la cosiddetta striscia morbida. Era una striscia di terra, larga quattro metri che, dopo essere zappata per bene, veniva spianata accuratamente con dei rastrelli in modo da poter lasciare le impronte nella terra morbida.
La postazione militare albanese che faceva da guardia al confine era tra il clone e la stessa linea di confine. Quando qualcuno cercava di scappare, doveva per forza distanziare i fili del clone, per creare un varco da dove attraversare. Se due fili si toccavano tra loro, veniva creato un circuito elettrico. Un allarme suonava al posto militare più vicino. Immediatamente, i soldati, armati di pistole e torce, correvano verso la zona del circuito, bloccando tutti i sentieri probabili dove ci si poteva passare. In tal caso, solo una piccolissima dose di fortuna, la pioggia, la nebbia o il terreno troppo montuoso potevano essere d’aiuto a chi stava rischiando la vita.
“Fuggiremo via mare”, disse Klement alle due sorelle, “noi tre sappiamo nuotare molto bene. Vi ricordate quando eravamo piccoli e andavamo al mare a Durazzo? Faremo lo stesso ora.”
Per fuggire, scelsero la città più meridionale, Saranda. Dalle carte geografiche della scuola sapevano che l’isola greca di Corfù non distava più di 10 km da Saranda. Però, se si fossero spinti più a sud, verso il villaggio di Ksamil, la distanza si sarebbe ridotta, fino a raggiungere due o tre chilometri.
Nessuno li avrebbe permessi di scendere fino a Ksamil, perché era considerata zona di confine! Ma almeno, fino a un punto della costa dove la distanza può essere di 5 km, potevano avvicinarsi a piedi. Le luci di Corfù sembrano molto vicine.
Bastava solo allenarsi, avere fiducia e coraggio in loro stessi e ci sarebbero riusciti a raggiungere la loro libertà. Avevano l’anima libera, ma il corpo prigioniero.
Le sorelle acconsentirono.
Scelsero il mese di agosto per fuggire. Non solo perché durante l’estate a Saranda c’erano molti vacanzieri, ma perché quel mese si sarebbero svolti i Giochi Olimpici a Los Angeles. Pensavano che, essendo un’atmosfera sportiva anche in TV, l’attenzione della polizia e dei soldati sarebbe stata meno severa.
Dato che de jure non erano più internati, le autorità avevano dato loro il permesso per qualche giorno di vacanza. Era fine luglio 1984, salirono su un vecchio camion Zis e partirono. Il padre li accompagnò al piazzale del paese, per non essere notati, quando si salutarono, evitarono di abbracciare il loro padre.
In serata giunsero a Saranda, per fortuna trovarono posto nell’unico hotel della città.
Il giorno dopo, subito dopo pranzo, si avviarono a piedi verso Ksamil, prendendo la strada provinciale, per potersi avvicinare più possibile a sud, cioè più vicini a Corfù.
Camminarono finché non trovarono un posto di blocco con i soldati armati. Soltanto i residenti della zona che avevano permessi speciali potevano procedere oltre.
Aspettarono la sera nascosti tra le rocce. Verso le ore 21, quando erano pronti per partire, un proiettore potente illuminò l’intero mare. I tre si nascosero tra le rocce e non si mossero. Il proiettore era un imprevisto.
Rimandarono la loro fuga per il giorno successivo. Almeno, avrebbero imparato con che frequenza si accendeva e si spegneva quella maledetta luce.
Il proiettore illuminò il mare per mezz’ora e poi venne spento. Per poi, essere riacceso di nuovo alle ore 23.
All’indomani dovevano partire per le 21:30 e nuotare sodo per essere già in mare aperto alle 23, dove la luce del proiettore non poteva raggiungerli. Le luci di Corfù, sarebbero state la loro bussola.
Era mezzanotte passata quando tornarono in albergo. Per fortuna non attirarono l’attenzione di poliziotti o agenti civili.
Il pomeriggio successivo, era il 1 agosto 1984, si diressero di nuovo a sud.
Camminarono ancora più al sud, rispetto al giorno prima. Arrivarono di nuovo al posto di blocco dei soldati e dissero loro che venivano da Tirana per una vacanza, e che volevano godersi le meraviglie della costa, chiedendoli il permesso di passare per un giretto veloce.
L’aspetto da gente istruita, il loro abbigliamento dai colori chiari, il modo di parlare, l’accento di Tirana e la presenza delle ragazze, hanno fatto pensare ai soldati che si trattasse dei figli di qualche alto dirigente del Partito.
Probabilmente, alcuni di loro non erano mai stati a Tirana. Non c’è da stupirsi. I soldati di frontiera, di regola, venivano selezionati tra i figli delle famiglie leali del regime, che possibilmente vivevano in aree remote o lontane dalle principali città. Saranda stessa, come tempo percorso, era quasi una giornata di viaggio lontano da Tirana.
A loro grande sorpresa, i militari non notarono alcuna emozione sui volti dei tre giovani, lasciandoli proseguire per la loro gita.
Nel luogo che i cittadini locali, a causa delle rocce piatte sul mare, chiamano “Le piastrelle”, ne trovarono una piccola baia rocciosa e si nascosero. Aspettavano impazienti le 21:30, quando il proiettore terminò la sua prima illuminazione. Senza perdere tempo, nascosero i vestiti tra le rocce, dopo essersi abbracciati, si tuffarono in mare.
Sulla destra avevano Saranda, mentre davanti Corfù, la loro destinazione. Dio ci benedica, si sono detti l’un all’altro, qualunque sia il nostro destino, che avesse pietà dei nostri genitori anziani che abbiamo lasciato soli!
Era mercoledì 1 agosto 1984. Bela aveva 30 anni, Klement 28, Zamira 27.
I loro cuori tremavano di emozione e ansia mentre nuotavano verso le luci di Corfù senza mai voltare la testa indietro per non perdere nemmeno un secondo. Bela, la maggiore, nuotava in mezzo ai due. Aiutandosi sempre, dandosi coraggio e forza.
Erano lontani dalla costa albanese quando il proiettore si riaccese.
Nuotavano incessantemente. Ma, al largo, le correnti li separavano l’uno dall’altro. Questo non lo avevano mai previsto. Non potevano nuotare in gruppo a causa delle onde. Tra di loro si tenevano in contatto vocale, quando qualcuno chiamava una “O” prolungata, gli altri due rispondevano lo stesso.
– Oooo!
– Ooooo!
– Ooooo!
Le luci di Corfù si avvicinavano sempre di più, ma la costa non si avvicinava mai.
Forza un altro po’, forse soltanto ancora una o due ore…
Era quasi l’alba quando la stanchezza iniziò a farsi sentire. Sempre di più non sentivano le braccia e la testa era pesante come il piombo! Lentamente, le loro palpebre cominciarono a chiudersi.
Bela, si chiedeva quando sarebbe finita quella tortura, era stanca, assetata, la bocca secca, lo stomaco che bruciava dal sale del mare. Aveva i crampi ovunque nel corpo ma ciò che rendeva più difficile tutto erano i dubbi che le assalivano in testa. Se fosse stato annegato in mare, se non ci riuscisse mai a raggiungere la costa… ma comunque era sempre meglio annegare in mare, che vivere sotto il regime in Albania.
Sentiva troppo freddo…
Vedeva la luce e si chiedeva se fosse già l’alba o forse dormiva, come avrebbe nuotato se avesse dormito? Notava qualcosa che si muoveva sull’acqua, sembrava l’ombra di un uomo che portava a spasso il proprio cane. Dovrebbero essersi in terraferma poiché il cane saltellava dietro al padrone, quindi erano vicino alla costa… O forse era un sogno?! No! No! Si vedevano degli alberi verdi dietro a loro.
Forza Bela, muovi le braccia, nuota ancora un po’. Lì dov’è quel signore con il cane c’è la libertà, lì finisce la sofferenza. Forzaaaa!
Ma Zamira e Klement dove sono scomparsi?! Non chiamavano, non sapeva se fossero vicino alla costa. È stata invasa da una immensa paura che forse loro… No, no, sono partiti tutti e tre insieme e insieme dovevano raggiungere l’altra riva. Gli occhi le bruciavano dal sale e dalla stanchezza.
Erano le 9 del mattino quando Bela Islami, ormai sfinita, si avvicinò a uno yacht ancorato non lontano dalla riva. Il proprietario, un italiano, l’ha trascinata a bordo. In pochi minuti trovarono, mezza morta anche Zamira, che stava quasi annegando in mare. Rimase solo Klement. Hanno cercato ovunque…
Le sorelle lo chiamavano ad alta voce in modo da poterlo svegliare in caso si fosse addormentato. Li chiedevano di alzare il braccio nel caso non avesse più voce per rispondere. Lo incoraggiavano essendo vicino alla riva a sentire il rumore dello yacht e avvicinarsi assicurandolo che a bordo c’era posto anche per lui. Hanno cercato ovunque il loro fratello, egli aveva resistito al carcere, al manicomio, alla persecuzione, quindi sicuramente avrebbe superato con successo anche quest’ultima sfida.
Klement! Klement! Klement, chiamarono ovunque, ma inutile…
Hanno cercato per ore, anche nei giorni successivi. La capitaneria del porto ha inviato motovedette lungo la costa, i pescatori della zona hanno controllato ovunque. Ma Klement, fratello di Isabella e Zamira, non fu mai ritrovato. Il mare non ha mai restituito il suo corpo.
L’eroismo delle due sorelle albanesi e del loro fratello ha riempito le prime pagine dei giornali dell’epoca nei paesi occidentali.

Solo in Albania, per il loro gesto non si è mai parlato ufficialmente.
Nel dicembre 1984 le due sorelle ottennero asilo politico in America e vi si trasferirono. La comunità politica albanese di Detroit le ha adottate. Non appena hanno perfezionato il loro inglese, hanno iniziato a lavorare alla radio Voice of America, nella sezione albanese.

Inizialmente con pseudonimi e poi con nomi veri, le loro due voci divennero emittenti di notizie provenienti in Albania dal mondo libero.
Il governo albanese, due mesi dopo la fuga, ha internato di nuovo i loro genitori anziani nel piccolo villaggio di Berisha, sulle montagne di Puka.

Ogni sera, alle 18, i due anziani chiudevano a chiave la porta della capanna dove vivevano e abbracciati accendevano la radio di nascosto per sentire le voci delle loro figlie.
Il padre morì nel 1988 senza aver mai più rivisto le sue figlie.
La madre, fino al 1990, ha vissuto in esilio. Nello stesso anno, quando il regime era già caduto, ottenne il visto e arrivò in Italia. Da lì, è volata in America, dalle sue due figlie.
Dove ha potuto godere alcuni degli unici giorni di libertà.
Questa è la storia di Bela, Zamira e Klement Islami, tre giovani che hanno sfidato il regime e le capacità fisiche umane.
Le due sorelle vivono ancora in America, dove ogni 2 agosto la famiglia celebra il giorno della loro libertà, così come purtroppo, anche l’anniversario della morte del fratello.
Bela Islami è tornata in Albania per la prima volta, nel 1993. Ha accompagnato l’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter come giornalista durante la sua visita a Tirana.

Zamira non ha ancora vinto la guerra con i suoi fantasmi, traumi e sofferenze subite: non ha mai trovato la forza per visitare il suo paese…
PS- Ho sentito la loro storia per la prima volta quell’anno in cui sono scappati. A Tirana, tra i giovani, si sussurravano i loro nomi con ammirazione.
Nell’estate del 1987 ero a Saranda e un ragazzo del posto mi disse che a pochi metri di distanza, da dove stavamo facendo il bagno, proprio a Le Piastrelle, erano partite le due sorelle albanesi per Corfù, notizia che aveva visto di nascosto nella televisione greca.
Fino al 1991, quando ho lasciato l’Albania, quasi tutti i pomeriggi, sentivo le voci delle due sorelle che trasmettevano i notiziari VOA. Già, la loro storia e i loro nomi erano diventati leggenda.
Anni fa, in una discussione che abbiamo fatto su Facebook sul loro gesto, ho parlato con i superlativi del loro esempio e coraggio nel sconfiggere la schiavitù.
Ho sottolineato il fatto che il loro eroismo meritava, almeno un film…
Il giorno dopo mi squillò il telefono.
– Pronto, -dissi.
– Sono Bela Islami, di Washington, – rispose una voce di donna, piena di accento americano…
Fu una bella sorpresa, oltre che emozione pura, parlare per quasi un’ora con una ragazza, -adesso donna- che insieme ai suoi fratelli, aveva scritto una delle più eroiche pagine della lotta per la libertà durante gli anni bui della dittatura…