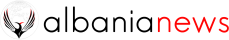«È un libro bellissimo, ma non fa per me. Io cerco dei libri sullo stile di vita americano, libri che parlano dell’America. Mi spiego? Invece questo parla della Prima Guerra Mondiale»,- mi dice Arjan, allungandomi “I tre amici di Remarque.”
«Voglio leggere come si vive in America! Questa è la cosa che m’ interessa. Te l’ho sempre detto.»
«Come faccio a trovarti l’America, Arjan?!», rispondo. «Nessuno traduce più libri americani… Sono proibiti. La gente ha paura, lo sai.
Ci troviamo davanti alla porta del mio appartamento. Arjan, come al solito, mi ha riportato l’ennesimo libro prestato chiedendomi puntualmente uno nuovo. Negli ultimi tempi cercava costantemente libri stranieri, libri che raccontavano storie moderne dei nostri giorni. Dove potevo procurarmi libri del genere?! Erano pochi.
Libri albanesi, compresi quelli di Kadare, ne avevo tanti, quanti ne voleva, ma a lui non piacevano.
Da un anno ormai ci eravamo diplomati al Politecnico. Arjan non aveva mai eccelso negli studi. I libri della scuola non li aveva mai aperti con gran voglia. Si accontentava di un voto sufficiente e non si impegnava più di tanto. In compenso, leggeva tutti i romanzi che gli capitavano tra le mani.
«Te l’ho prestato “Una tragedia americana” di Dreiser?»,- gli chiedo. «È un libro bellissimo. Solo che racconta una storia di circa sessant’anni fa. Un povero ragazzo diventa ricco e s’innamora di una sua dipendente.»
«Portamelo presto, senza perdere tempo! Potevi darmelo prima.»
I suoi occhi, appena sentono la parola “America”, brillano.
Entro immediatamente in casa. Il libro promessogli lo trovo nella biblioteca del mobile da mille seicento lekë. Sul solito quaderno scrivo il titolo, la data ed il nome di Arjan e mi affretto a raggiungerlo nel pianerottolo. I libri che presto da leggere, li annoto tutti. Chi li porta via, non sempre rispetta la data delle consegne. Dopo di lui, il libro se lo leggono i cugini o gli amici vari.
I bei libri non sono così facili da trovare, poiché, per ragioni sconosciute, vengono stampati in tirature limitate. Anch’io riesco a malapena a trovarli. A mio zio non mancano mai tali libri, e spesso, li prendo da lui. Ovviamente, senza avvisarlo affatto. Sottrarre un libro per migliorare la propria cultura e aprire gli occhi non può essere considerato un furto. Soprattutto, quando lo si porta via all’amato zio.
«Prendilo, ma, per favore, portamelo in tempo perché è un libro raro»,- dico ad Arjan,- consegnandoglielo avvolto in un pezzo di giornale per mascherarlo. «Termina il primo volume e poi vieni a prendere il secondo.»
«Stai tranquillo! Mi sa che mi divertirò con queste storie americane. Appena lo finisco, te lo riporto.»,- risponde Arjan salutandomi. Scende velocemente le scale e se ne va.
Senza dubbio, il libro l’avrebbe divorato in pochi giorni! Chiudo la porta e sorrido. Come cambia la gente!
Arjan e io siamo amici sin dall’infanzia. Amici veri, ma anche avversari degni. Avevamo frequentato insieme la scuola materna n. 52, quella del nostro quartiere, a Tirana. Lui, era il capitano della squadra “Tirana” della materna, mentre io ero il capitano della squadra dell’altro gruppo che, ovviamente, si chiamava “Partizani”. Noi, della Partizani, vincevamo sempre a calcio. Lui e la sua squadra non accettavano mai con serenità il risultato delle partite.
Una volta accusavano il vecchio Sadik, il custode della materna che tutti chiamavano zio, di non aver concesso due rigori alla loro squadra (ci faceva lui da arbitro). Altre volte, se la prendevano con il nostro portiere, Ardi, secondo loro c’era il suo zampino dietro le dimensioni stranamente ridotte della nostra porta, avvicinando le pietre che servivano come pali. E quando non trovavano più argomenti validi per difendere le loro tesi piagnucolone, in collaborazione con la zia Mereme, la bidella, sostenevano ad alta voce che zio Enver stesso era un fan della “Tirana”.
Come mai lui viveva a Tirana?! Facile, per poter fare tifo alla “Tirana”! Apriti cielo! Facendo corpo intorno alla bionda maestra Eugenia, la mia squadra giurava, mettendoci la mano sul fuoco, che il caro zio Enver era un fan della “Partizani”. Sennò, cosa ci faceva come comandante supremo dei partigiani, come avrebbe fatto ad uccidere con il suo fucile tanti fascisti e nazisti durante la guerra!
… Le nostre discussioni proseguivano fino a tardo pomeriggio, quando, stanchi dal lavoro e dalle lunghe file quotidiane nei vari negozi, i genitori non si scordavano mai di venire a prenderci da scuola. Ci si salutava e, mentre saltavamo tra le braccia di mamma o papà, non ci si stancava mai di chiedere anche a loro per quale squadra tifava zio Enver.
Il giorno dopo ci si ritrovava di nuovo assieme. Giochi nuovi, discussioni vecchie.
Con il finire della materna, finirono anche i nostri giochi e le nostre discussioni; poi andammo in scuole primarie diverse.
Con Arjan, facemmo pace solo otto anni dopo, quando ci siamo ritrovati di nuovo insieme, al Politecnico. Anche se in classi parallele, legammo ancora di più. Abitavamo vicini e ci vedevamo ogni giorno sull’autobus di linea che ci portava a scuola. Anche al Politecnico avevamo istituito la nostra squadra di calcio. Io facevo il portiere, mentre suo cugino era il centravanti della squadra. Arjan faceva sia da allenatore che da magazziniere, il quale, in quei tempi aveva anche l’incarico di custodire i nostri indumenti durante le partite. Quando era necessario, svolgeva anche il ruolo di guardaspalle. Non si tirava mai indietro se c’era da battersi con qualcuno. Aveva messo dei muscoli e non conosceva la paura. Era coraggioso, ma taciturno.
Quando al Politecnico terminarono i nostri studi, le nostre strade si divisero di nuovo. Iniziammo a lavorare in aziende diverse e ci incontravamo di meno. Comunque, Arjan continuava a non mancare in nessuna delle nostre partite al campo del Palazzo dei Pionieri o a quello di terra battuta del quartiere 21 Dicembre, ma nel muretto della piazza Scanderbeg, dove ci si incontravano tutti i giovani di Tirana, cominciò a farsi vedere sempre meno. Aveva compagnie nuove ormai, come i ragazzi del suo quartiere. Certo, abitando in periferia (solo chi abitava in centro città era degno di argomenti di qualità), con quei amici non è che poteva discutere sul campionato italiano del calcio, sull’ultima moda o, per dire, sui Queen. Le loro conversazioni contenevano argomenti di carattere fisico: il tessuto muscolare, i bicipiti, i pettorali, le varie forme del corpo, ecc.
E, coerenti fino alla fine con la loro filosofia, tutti quanti loro, durante la primavera e l’estate, si recavano ogni i giorni nel lago di Linza che distava mezz’ora di camminata dal nostro quartiere. Nuotavano per delle ore e per dei chilometri. Senza sosta. Quando arrivava l’inverno, la loro attenzione si rivolgeva agli attrezzi ginnici situate nel cortile di una scuola secondaria. Si allenavano per diventare culturisti.
Delle volte avevo chiesto ad Arjan perché prestava così tanta attenzione al nuoto e alle parallele. Come mai gli era venuto tutto questo desiderio verso il culturismo? Come può uno, pretendere di avere una bella corporatura quando non riesce neanche a mangiare decentemente?! Può il corpo umano far fronte all’allenamento fisico mettendo giù nello stomaco, per pranzo, solo un uovo fritto e due pezzettini di formaggio bianco simile al Feta? Tutta questa fatica aveva senso? Non era meglio che venisse con noi nel gran Giro di Tirana? Di belle ragazze ce n’erano tante. Loro, al momento guardavano la sostanza e non la forma. A nessuna interessa il bel corpo. Non possiamo diventare tutti dei culturisti come Alessandro Kondo (NdA-campione d’Albania, in epoca, in sollevamento pesi, noto anche per il suo fisico da culturista. Era considerato un’icona in Albania. Fuggì in Occidente, nel 1985, durante una trasferta sportiva). Lui è un’eccezione.
Arjan sorrideva. Con tanta pazienza mi spiegava che sì, davvero lui si allenava ore intere per avere un bel fisico, ma non si scordava mai di allenare anche la mente. Come mai vengo da te e prendo tutti questi libri?! Perché non mi soddisfa solo l’aspetto delle cose, ma anche il contenuto. I tempi sono cambiati. Ora le ragazze guardano non solo l’aspetto fisico degli uomini, ma anche la padronanza e la fluidità del linguaggio. Non per niente il Partito ci insegna: “Mente sana in corpo sano”. Vedi che obbedisco a quello che ci raccomanda il Partito?
… E ridevamo come dei matti.
Va bene, Arjan, va bene! Però, con questi pantaloni da cowboy che indossi, pensi di far colpo sulle ragazze?! Beato te che ci conti! Ahimè, oggi vanno di moda i pantaloni attillati a tubo!
E ci si salutava. Lui continuava con il suo nuoto e i suoi ferri, io, come al solito, sostavo alla cosiddetta “Bordura”, il solito muretto. Era il nostro mondo.
… Era passato più di un mese da quel giorno di fine luglio, in cui gli avevo prestato il primo volume di ‘Una tragedia americana”. Arjan era in ritardo e non mi aveva ancora riportato indietro il libro. Di solito i libri che gli prestavo li finiva in settimana. Non di più. Che l’avesse dato a qualcun altro il mio libro? O forse ad agosto era andato in vacanza a Scutari, dai suoi cugini, dove si recava abitualmente e non aveva avuto tempo di finirlo. Ma lui non vedeva l’ora di procurarsi libri del genere!
Con questi pensieri nella testa e con un certo risentimento, un giorno di metà settembre, sono andato da lui. Presi con me anche il secondo volume del libro. Meglio che glielo porti io, pensai. Almeno, non si sarebbe capito che ero andato fino là solo per chiedergli indietro il libro. Non sarebbe stato un comportamento molto elegante il mio. Il debito non può essere richiesto mai indietro agli amici. La gente ha anche degli altri problemi.
Quei pochi metri di distanza che separavano casa mia dalla sua li feci in cinque minuti. Faceva caldo. Le strade erano piene di scolari che si affrettavano a comprare gli ultimi materiali che servivano a loro per l’anno scolastico appena iniziato. Altri giocavano ancora a pallone. Le bambine ovviamente giocavano con delle “peta” (NdA-un gioco con delle mattonelle o sassi piatti e levigati, molto diffuso all’epoca).
Ero ad un centinaio di metri dalla palazzina dove abitava Arjan, un piccolo edificio a due piani con mattoni bianchi, quando notai che attorno c’era più gente del solito. Rimasi un po’ sorpreso. Forse c’era qualche evento famigliare. Era fine settimana. Mese delle nozze. Tanto più mi avvicinavo, più persone notavo. La cosa strana era che le persone stavano ad una certa distanza dalla palazzina e non si parlavano nemmeno sottovoce. Allora non si sposa nessuno, perché neanche si sente suonare della musica. Mah! E se fosse morto qualcuno? Sì, è probabile. Ecco perché nessuno parla. Speriamo che non sia successo niente alla famiglia del mio amico! Ma io non ho visto nessun manifesto funebre ai lampioni della luce dove in genere si affiggevano. O forse l’hanno messo all’ingresso della palazzina. E quelle due jeep là, cosa ci fanno davanti alla casa? Cosa sono? Perché esattamente proprio lì e non da qualche altra parte? Non ci sono funzionari che abitano lì. Il padre di Arjan lavora come geologo e tutti sanno che i geologi non hanno auto quelle auto. Martelli e picconi hanno loro. In più, quelle due Jeep sono di color’ verde scuro, assomigliano a quelle dei militari o dei servizi segreti.
Molto strana la cosa! Mi avvicinai e guardai intorno per conoscere qualche volto familiare, ma non notai nessuno. Le persone si erano fermate ai lati della strada in silenzio. I loro sguardi erano diretti verso la palazzina di Arjan, dove si trovavano anche le jeep. Pensai di chiedere a qualcuno perché ci fosse così tanta gente lì, in quel momento. Cambiai idea subito. Alla mia curiosità si era unita anche una sorta di misteriosa riluttanza. Meglio chiamarla paura. Forse, non era nemmeno il caso di fischiare ad Arjan (NdA-in quei tempi, solo pochi funzionari avevano un telefono a casa. Era solito tra i ragazzi chiamare uno l’altro fischiettando). E quelle due jeep, cosa ci fanno? Fossero dei camion “Zuk” carichi di legna da ardere, vabbè, ma due jeep?! Cosa faccio?
Non fermai il passo, ma proseguii ancora. Mi allontanai per una trentina di metri e girai all’angolo di un altro palazzo. Decisi di tornare da dove ero venuto e di guardare con più attenzione.
Accanto a me, due bambini che bisbigliavano tra loro, interruppero i miei pensieri. Potevano essere in terza elementare, non di più. Parlottavano tra loro guardando nella direzione delle jeep e verso la casa di mio amico. Mi rassegnai alla mia curiosità.
«Ehi, piccolo», -dissi a quello che parlava più dell’altro,- «è successo qualcosa qua, in questa palazzina?»
I bambini si zittirono immediatamente. Girarono la testa verso di me e, quando videro che ero solo un giovanotto, si rasserenarono. Il più sveglio girò gli occhi neri da destra a sinistra e si fece avanti. Uni le mani alla bocca e si avvicinò al mio orecchio. Serio, come se stesse dicendo un segreto d’amore, mi sussurrò una frase. Solo una.
«Cosa?!» questo era tutto ciò che potei dire. «Che dici? Come fai a saperlo, te?»
Cos’era quella parola?! Non è che ho capito male?! Lo fissai dritto negli occhi. Rivolsi immediatamente lo sguardo anche al suo amico. Anche i suoi occhi mi confermarono ciò che avevo appena sentito.
Alzai la testa come per chiedere aiuto. Incrociai lo sguardo di un uomo accovacciato, appoggiato al muro. Doveva abitare lì, nelle vicinanze. Ci guardammo negli occhi per alcuni secondi, fino a quando mosse leggermente la testa per inalare la sigaretta con le dita ingiallite dalla nicotina. Aveva capito la mia domanda. Con lo sguardo impensierito mi diede la stessa risposta. Quella che mi avevano dato i due bambini. Girai la testa verso gli altri. Da lontano, domandai anche loro con lo sguardo. Mi risposero con i loro sguardi, in silenzio.
Senti le mie gambe tremare. Decisi immediatamente di andare via. Prima con un passo lento. Poi, quando me ne allontanai un po’, accelerai di più. Alla fine, mi misi a correre. Le ginocchia mi tremavano. Il cuore mi batteva forte. Non riuscivo a respirare. Sentivo la testa pesante. Non riuscivo a capire più niente. Sentivo il bisogno di incontrare qualcuno. Di dirgli tutto quello che avevo sentito. Decisi di andare al nostro muretto “Bordura.” Tra poco, tutti gli amici si sarebbero radunati li. Avrei dato anche a loro la notizia.
Era come se qualcuno mi stesse correndo dietro. Continuavo costantemente a girare la testa. Per fortuna, nessuno mi seguiva. Nemmeno una delle due jeep. Perché avrebbero dovuto farlo? Io mi ero comportato bene. Ero un bravo ragazzo. Solo libri prestavo, io! Si, è vero, nella prima pagina di ogni libro avevo scritto il mio nome, ma questo non è un reato. Io non posso sapere cosa fa la gente, dopo aver letto un libro della mia biblioteca. Ma è un libro proibito il tuo? Come faccio a sapere?! La loro lista cambia in continuazione e nessuno avvisa degli aggiornamenti. Almeno, ufficialmente. Poi, sottovoce, la gente ne dice di tutto: uno dice qualcosa perché sa qualcosa, un altro lo fa per paura, altri, perché vogliono far vedere che sanno delle cose segrete.
Cavolo! Avrei voluto arrivare da qualche parte! Correvo, ancora! Rallentai alla fermata degli autobus. Non c’era tanta gente, là.
«Amico, non aspettare invano, non ci sono autobus!»
Girai la testa. Un ragazzo del quartiere, che non conoscevo molto bene, mi stava parlando.
«Perché non ci sono autobus? Cos’è successo?»
«Domani è il 16 settembre, vecchio, è la festa di Peza. Non te lo ricordi più? (NdA- A Peza, vicino a Tirana, nel 16/9/1942, si tenne una conferenza di tutte le forze politiche ed armate dell’Albania, con lo scopo di riunirsi nella lotta contro l’esercito fascista. È una festa nazionale che si festeggia tutti gli anni).
«Che c’entrano gli autobus con Peza?», gli chiesi sorpreso.
«C’entrano, come no. Tutti gli operai li trovi a Peza oggi, a festeggiare. Quindi, non ci sono autobus, sono andati tutti a portarci la gente.»
Entrai nel bar di fronte all’Accademia Militare e chiesi un bicchiere d’acqua. La barista si mostro disponibile e me lo diede. Visto che dentro faceva caldo, gli avventori del bar stavano fuori, con i bicchieri degli alcoolici in mano.
Bevvi l’acqua tutto in un sorso e uscii fuori. Iniziai a camminare verso il centro …
Girai la testa indietro per l’ultima volta. Non notai nessuna cosa sospetta. La gente al bar brindava contenta. Viveva per l’alcool certa gente. La loro felicità costituiva nel riempire i bicchieri. Io e i miei amici vivevamo solo per le ragazze e per lo sport. Gli altri erano andati a celebrare a Peza.
Invece Arjan, insieme ad un altro amico, cinque giorni prima, aveva attraversato a nuoto il lago di Scutari ed era fuggito in Jugoslavia.
Doveva ancora compiere vent’anni, il mio amico. Che coraggio, Arjan! Che impresa! Che fortuna!
Non me la sarei mai aspettato da uno che parlava così poco. Senza troppi proclami, se ne era andato per sempre verso la libertà. A nuoto! Ma come cavolo aveva fatto, a vent’anni non si è ancora formati del tutto fisicamente?!
Lì capii il perché della sua ossessione per i libri e per il culturismo. Si preparava a fuggire da tempo e voleva essere molto preparato in tutto. Era molto più avanti di noi, lui, pensava al futuro.
Pensava alla libertà!
Addio, Arjan! Addio amico mio!
Addio, uomo libero!