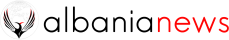Verso la metà del secolo XV, giunse a Forlì un personaggio straordinario, la cui presenza in città e nel contado avrebbe sollevato un interesse “popolare”, per la sua imponenza, per la sua condotta di vita, per la sua intraprendenza di farsi fermento in quella società, sia dal punto di vista religioso che culturale.
Chi era questo uomo, di origine straniera, dall’esistenza condotta in maniera al tempo stesso riservata e, d’altra parte, tale da non passare inosservata e quasi da porsi come “faro” nuovo alla sensibilità ed alle coscienze dei suoi nuovi concittadini?
Già: chi era? Perchè il primo punto misterioso, tutt’ora perdurante, di quella persona riguardava la sua identità sociale, il suo stato civile. Ancora oggi molti si chiedono se fosse un monaco, addirittura un eremita, o un pirata, poi convertitosi. Le tre Cronache coeve lo indicano come un monaco, e tante altre ragioni collaterali rafforzano decisamente questa interpretazione; ma per storici forlivesi successivi si fece strada la suggestiva, romanzesca e romantica ipotesi che fosse un ex-corsaro, predone in Adriatico, chissà come poi passato ad abbracciare vita religiosa.
Su una cosa tutti sono, e devono essere, d’accordo: proveniva dall’Albania. Tutti lo hanno denominato e fatto conoscere come Pietro Bianco da Durazzo.
È egli stesso che ce ne fornisce la prova, incisa sulla pietra, nell’iscrizione dedicatoria di ciò che lui con più risolutezza ha desiderato costruire nella quieta campagna fra Forlì e Forlimpopoli, lungo la direttrice di quella via “Cervese”, che aveva percorso dal litorale all’entroterra: un Santuario votato alla Madonna di Misericordia e di Grazie, nel sito detto di Fornò.
“LʼANNO DEL GIUBILEO 1450 MI PIERO BIANCO DA DURAZZO PRINCIPIAI QUESTA CHIESA DI SANTA MARIA DI MISERICORDIA E DI GRAZIA FACTA CON TUTI I BENI E ORNAMENTI SUOI BELLISSIMI A DIO NOSTRO DILETTISSIMO SIGNORE DEGNISSIMO SALVATORE ETERNO PER SEMPRE IN SECULA.”
Questo si legge ancora nitidamente sia all’esterno che all’interno del portone di ingresso della chiesa capolavoro dell’Umanesimo italiano, imponente per dimensioni (particolarmente impensabili per il sito extra-urbano), per la peculiarità di un’architettura dal corpo rotondo sormontata da tiburio ottagonale -così precisa e ardita da dover necessariamente scomodare Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti-, per i capolavori di scultura e pittura che custodisce (o che ha custodito).
Ma cosa poteva avere spinto il nostro monaco alla venuta in Italia?
La ragione è da ricercarsi nella difficile situazione ambientale venutasi a creare nel “Paese delle Aquile”. Fra il XIII e il XVI secolo, quando in Albania si affermò progressi-vamente la religione islamica, in seguito alla conquista ottomana, si distinsero due grandi ambiti territoriali entro i quali sopravvisse l’elemento cristiano: il settentrione, influenzato dalla cristianità latina; il meridione, da quella greco-ortodossa.
Vi era anche la forte presenza della Serenissima Repubblica di Venezia(parte di quei territori erano denominati “Albania veneta”(1420-1479), soprattutto nell’Albania settentrionale, in particolare intorno a Scutari e Durazzo (ma con la conquista turca del 1479 ridotta all’area montenegrina). Papa Bonifacio IX, il 13 dicembre 1402, sollecitato dal ministro provinciale dei francescani di Dalmazia, aveva istituito una nuova custodia a Durazzo, comprendente i conventi di Antivari, Dulcigno, Alessio e Durazzo stessa.
Più tardi, 1431, papa Eugenio IV chiamò in suo aiuto i più affermati predicatori francescani dell’epoca, tra cui si ricordano: San Bernardino da Siena e i successori Alberto da Sarteano e Giacomo della Marca, nonché fr. Giovanni da Capestrano, fr. Lodovico da Bologna.
L’opera fu proseguita da papa Niccolò V, mentre l’Albania era guidata da Giorgio Castriota Skanderbeg(1405-1468), per 25 anni a capo della lotta dei principi albanesi contro gli ottomani di Murad II e poi di Maometto II il Conquistatore.
Il pericolo di un’invasiva sottomissione imponeva un intervento deciso, sicché il 1° gennaio 1443 Eugenio IV indisse una crociata chiamando a raccolta tutti i cristiani in aiuto dell’Albania, dell’Ungheria e della Repubblica di Ragusa che costituivano il baluardo più esposto all’offensiva turca.
Così, il 2 marzo 1444, nella cattedrale veneziana di San Nicola ad Alessio, Skanderbeg organizzò un grande convegno con la maggior parte dei principi albanesi; un’assemblea che riuniva la quasi totalità dei nobili albanesi che avevano condotto le prime insurrezioni contro i turchi: gli Arianiti, i Thopia, i Dukagjini, i Korona-Muzaka, i Balsha, ansiosi di difendere i loro possedimenti feudali contro gli ottomani. Vi partecipò, ovviamente, anche il rappresentante della Repubblica di Venezia.
In questo convegno il Castriota fu proclamato all’unanimità come guida della nazione albanese. Lo scontro con le forze di Skanderbeg, notevolmente inferiori, avvenne il 29 giugno 1444, a Torvioll, dove i Turchi riportarono una cocente sconfitta. Il successo di Skanderbeg ebbe vasta risonanza oltre il confine albanese, arrivò fino a papa Eugenio IV, il quale ipotizzò addirittura una nuova crociata contro l’Islam guidata dallo stesso condottiero albanese. Ma nel 1447 arrivò una seria disfatta. L’esercito di Skanderbeg e la sua gente, costretti ad abbandonare la loro terra, continuarono le loro vicende di “resistenza culturale” in Italia.
È perciò molto probabile che Pietro fosse un monaco in fuga da quella realtà, ormai in balia dell’occupazione musulmana e che non si sentisse più protetto né dai vecchi, né dai nuovi protettori della Chiesa albanese. Così, come tanti altri monaci, nobili e civili, ci si diede alla fuga, principalmente dalle città costiere e i loro dintorni. Al sec.
XV appartengono, infatti, le immigrazioni delle grandi famiglie albanesi: Durazzo e D’Estieni. I primi si diressero prevalentemente dapprima a Venezia e quindi si trasferirono a Genova (dove, nel 1573, un loro discendente, Giacomo Grimaldi-Durazzo, fu addirittura eletto doge).
I secondi, anch’essi orientati in un primo tempo a Venezia, si stabilirono successivamente in Provenza. Poli di intenso approdo, per ovvi motivi geografici e di presenza di porti, furono le Marche, attraverso Ancona, e la Romagna, attraverso Ravenna. Come è intuibile, ma come, d’altra parte, è attestato, gli emigranti albanesi portarono con sé ciò che di più caro possedevano riguardo la propria famiglia, le cose più preziose e, fra queste, le pitture con le raffigurazioni della Madonna. Per questo si registra un’intensificazione degli atti di pirateria durante le trasmigrazioni. l’attaccamento alle Icone, soprattutto mariane, spiega la volontà di riferirsi ad un’iconografia amata e venerata in patria. C’è una suggestione, che poniamo come domanda, anche se introduce probabilità tutt’altro che peregrine: quella specie di patronimico con cui conosciamo Pietro Bianco, “da Durazzo”, è da intendersi obbligatoriamente ed esclusivamente come provenienza geografica, o può e deve riferirsi anche alla sua “casata”? Nel secondo caso, avremmo addirittura un lontano (o prossimo?) parente del fondatore del Principato di Monaco!
Comunque sia, tutto concorre a dare finalmente una più plausibile identità al fondatore di Fornò: monaco, probabilmente di famiglia nobile o signorile, di grande cultura, conoscitore della lingua italiana e della predicazione di San Bernardino da Siena.

Pietro arrivò in Romagna verso il 1448 e a tutti si presentava come un eremita (romito, solitario de vita apostolicha) vestito con un saio bianco. Ben presto iniziò ad essere conosciuto dalla gente per la sua straordinaria devozione nel predicare le vie della Salvezza del Creatore, con pia affezione al “buon” Gesù ed alla Madonna misericordiosa. Venne descritto come un uomo robusto, che non indossava né camicia, né calze, né scarpe; viveva solo di elemosine e mangiava solo quando qualcuno gliene offriva. I testimoni, concordi, rilevano che parlasse assai poco e che non toccasse, per nessun verso, denaro.
Probabilmente la sua spiritualità era affine al movimento monastico francescano dell’Osservanza, promosso da Bernardino da Siena. Questi, negli anni precedenti, aveva predicato in tutta Italia, compresa Forlì, e stava per recarsi anche in Albania (dove mandò -peraltro- i suoi migliori e più fidati discepoli), quando la morte lo colse presso L’Aquila. A questo famoso Santo si deve la diffusione del simbolo della gloria di Cristo, del “Santo Nome di Gesù”, un cerchio con dentro le lettere IHS (Iesus Hominum Salvator), che si trova un po’ ovunque nel Santuario (compreso il suo monumento funebre). Tale simbolo, al cui tondo fanno corona come raggi solari, è abbinata la maiuscola elegante della lettera “M”, per ricordare Maria, la Madonna.

Dopo aver vissuto per qualche anno entro le mura di Forlì, in cui si costruì un’umile celletta, frequentatissima dai popolani attirati dal suo stile di vita, col sostegno del signore più munifico ed umanistico di sempre della città, Pino III Ordelaffi, pose mano al progetto dell’erezione del Santuario, in onore della Madonna. Sfugge pienamente la ragione della scelta del sito, Fornò: molto probabilmente per fuggire dalla “pazza folla”, anche se, a posteriori sicuramente, nacque la leggenda del ritrovamento, là, di una miracolosa icona della Vergine, quella posta all’interno, sull’altare maggiore, per la venerazione dei fedeli. Ora, quell’icona, una tavola in stile bizantino, omaggio alla Theotocos ed alla sovranità di Cristo(che icona vera e propria non è), Pietro non poteva né averla trovata, né portata con sé dall’Albania (come facevano tanti monaci in fuga dal pericolo incombente ottomano), per il semplice motivo che lui stesso è ritratto all’interno del dipinto, genuflesso in preghiera. Oggi non rimane che una copia fotografica della sacra immagine, rubata nel 1986.
Il concorso di popolo al progetto del monaco fu estesissimo. La gente rimase conquistata da un suo innegabile carisma, dimostrandosi assai generosa in ogni tipo di elargizioni. Sotto la direzione del Bianco stesso, i lavori progredirono tanto rapidamente, che ben presto il nuovo tempio venne aperto al culto. Vi si recavano fedeli da ogni parte della regione stessa, fin da cento miglia di distanza. Nella prima domenica di ogni mese, tanta era l’affluenza di pellegrini e le offerte raggiungevano un valore talmente rilevante, da indurre Pino III Ordelaffi, Signore di Forlì e particolarmente amico di Pietro, ad inviare a Fornò una guardia armata. L’Eremita, che non volle mai toccare denaro, designò persone di fiducia in città, che, a suo nome, gestivano i proventi derivati dalle donazioni.
Sicuramente Pino III Ordelaffi ebbe un’influsso ed un ruolo decisivi in tutta la “fabbrica” di Fornò, ma il monaco albanese, d’altra parte, non tralasciò mai di proclamare come “sua” l’ideazione della nuova chiesa, come si evince dalle precise sue disposizioni di erigerla senza ricorso a chiavi di ferro, anche se ciò fu causa, già nel 1476, della genesi di crepe nella struttura edificata. Fu proprio quel fenomeno che, a detta dei cronisti, addolorò enormemente Pietro, fino a farlo precipitare in uno stato di malattia da condurlo ben presto a morte: il 6 aprile 1477, domenica di Pasqua.
La sua “creazione”, il Santuario di Santa Maria di Misericordia e di Grazie in Fornò, si presenta come primizia e capolavoro della recuperata chiesa a pianta centrale nell’Umanesimo: armonia compositiva di volumi perfetti.
L’uso di piante circolari, poligonali e a croce greca ben si adatta alle concezioni prospettiche del Rinascimento, in quanto consente, all’interno, di individuare univocamente il fulcro simbolico dell’aula sacra (ove viene collocato l’altare) e, all’esterno, di qualificare le diverse parti dell’organismo edilizio. La ricerca formale condotta in pianta, infatti, si estende anche agli alzati, polarizzando l’interesse degli architetti sulla complessità dei rapporti volumetrici tra il corpo principale e quelli secondari.
Nel caso di Fornò, vista la provenienza del fondatore, e verificatene le affinità di tipologia architettonica anche con altri edifici sacri italiani, di ascendenza più o meno bizantina, se ne può rintracciare una lontana primogenitura addirittura armena. Negli esempi armeni, infatti, l’organizzazione degli spazi è svolta dalla compenetrazione di volumi elementari: cilindri, cubi; calotte a mò di copertura per dare l’idea dell’universo; geometrie inscritte nel cerchio, come l’ottagono.

Alla preziosità dell’aspetto architettonico fa riscontro quello delle opere d’arte custodite dal tempio: da una Madonna col Bambino attribuita ad Agostino di Duccio, in nicchia sopra il pronao; ad un finissimo bassorilievo in marmo del medesimo autore rappresentante la SS.
Trinità; al sarcofago dello stesso Pietro Bianco da Durazzo; alle estese decorazioni ad affresco riportabili alle scuole di Melozzo da Forlì e di Marco Palmezzano.
Sono solo indicazioni sintetiche, che, mi auguro, portino molti visitatori a scoprire per intero i tesori nati dall’alta volontà culturale di un monaco albanese del Quattrocento, da annoverare fra la folta e qualificata schiera di artisti ed umanisti albanesi che contribuirono a rendere grande il Rinascimento italiano (i fratelli Laurana -fra Urbino e Napoli-, Jacopo da Dulcigno, ecc…).
Articolo di Marco Vallicelli, Professore al Liceo Artistico di Forlì