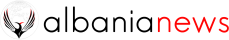Vive la sua infanzia e parte della sua giovinezza nella “gabbia dorata” del Blocco – il quartiere della nomenklatura di Tirana ai tempi del regime, riservato a tutti coloro che godono dei privilegi di Enver Hoxha – sino alla condanna e ai sedici anni di vita da esiliata. Vera Bekteshi torna ad assaporare la libertà con la caduta del regime e decide, dopo tanto tempo, di lasciare un’importante, dura e forte testimonianza di quel periodo, scrivendo un libro, La villa con due porte (Besa Muci, 2021). Raggiungo Vera telefonicamente e con la disponibilità che la contraddistingue, mi racconta e si racconta.
Hai atteso tanto tempo prima di scrivere La villa con due porte, così da poter parlare delle vicende guardandole con la giusta prospettiva. Cosa vuol dire, esattamente?
Volevo scrivere ponendo da parte la rabbia. Ho sempre avuto l’idea di mettere nero su bianco le mie vicende e mi dicevo: “Un giorno scriverò la mia storia”. Però, ho sempre rimandato per svariati motivi. Una volta, come tante altre, mentre ero in ufficio, (lavoravo per un’agenzia di infrastrutture), entrò nella mia stanza un funzionario francese e mi trovò, in un momento di pausa, intenta a giocare al “solitario”. Mi guardò e mi disse: “Vergognati! Perdi tempo a giocare al solitario e non ti dedichi alla scrittura della tua storia, che potrebbe essere interessante per tutti, non solo per voi albanesi. E poi, non puoi scrivere se fumi così tanto!”. Mi hanno molto colpito le sue parole, tanto da risuonarmi, quasi, come un ordine. Mi ha particolarmente impressionata la parola “vergognati”.
Esattamente a una settimana dalla sua partenza per il Canada, ho iniziato a scrivere, utilizzando lo stesso computer che usavo in ufficio, non possedendone uno tutto mio. Era il 2006. Ho scritto tutto il libro, cercando di dedicargli un po’ di tempo al giorno e così ci sono riuscita. In verità, non era la prima volta che scrivevo la mia storia. Avevo iniziato a mettere giù qualche rigo negli anni ’90. All’epoca, spesso, vi erano interruzioni di energia elettrica, per cui, mi servivo della luce di una candela per illuminare il foglio. Non ho mai utilizzato quegli scritti.

Nel libro narri, innanzitutto, della distruzione della tua famiglia per mano del regime, che a un certo punto se l’è presa con il generale Bekteshi e di riflesso con tutti voi. Tu eri molto giovane: hai mai, anche solo una volta, pensato che fosse colpa di tuo padre?
No, mai. Non ho mai pensato questo, perché per me, quanto accaduto non è stata una sorpresa. Io me lo sentivo che prima o poi sarebbe toccato a noi. Innanzitutto, perché mio padre era un generale maggiore e poi perché io ero “mentalmente libera” e questa modalità veniva vista come contraria ai principi del regime. Tanto è vero, che ero convinta che se non avessero punito mio padre, avrebbero penalizzato me. Invece, hanno colpito lui: Enver Hoxha aveva timore dei generali capaci, con esperienza, perché pensava avessero tutte le carte in regola per agire contro il governo.
Tuo padre è stato vittima, come altri, della cosiddetta “purga dei generali”. A tal proposito, tu sostieni, che l’idea di questa pulizia sia nata dalla paranoia di accerchiamento del dittatore. Mi spieghi meglio?
Hoxha era ossessionato dalla necessità di ordinare sempre “purghe”, affinché il popolo si sentisse costantemente in uno stato di isolamento, ma soprattutto di allerta. Egli doveva dare un senso all’esistenza dei bunker, che ha fatto costruire ovunque. La popolazione era tenuta sotto scacco dagli allarmi che suonavano spesso, affinché si sentisse minacciata dal bombardamento straniero e accorresse nei rifugi. Tenere le persone in costante allerta era, anche, un modo che il regime aveva per occupare la mente degli albanesi. Per esempio, gli studenti non dovevano avere molto tempo libero per pensare, perché poteva essere pericoloso per il governo. Durante le loro vacanze, infatti, venivano impegnati lavorando per lo Stato, senza alcuna retribuzione. Nessuno doveva stare fermo, perché l’immobilità portava il pensiero e il pensiero avrebbe potuto portare la consapevolezza. All’estero, spesso, gli studenti albanesi sono stati considerati una spanna sopra agli altri e molto più svegli, proprio per il modo in cui hanno vissuto, ma anche per l’educazione ricevuta secondo il modello russo-sovietico, basata su un algoritmo preciso e severo. I temi principali del romanzo, che attualmente sto scrivendo sono, proprio, la cosiddetta cospirazione dei generali e l’atmosfera che l’accompagnava.
A un certo punto, nel libro, parli della bellezza che accomunava le ragazze confinate e sottolinei come questo raggruppamento fosse studiato dalla Sigurimi, con la speranza che nascesse una sorta di “competizione” nel villaggio. Perché?
Una comunità di condannati vive male: tra gli schiavi non esiste solidarietà. Quando stai male in una determinata situazione, per uscirne o per sopravvivere ti aggrappi a qualsiasi cosa, danneggiando anche gli altri. Tra i confinati ci sono state molte piccole cattiverie, si può dire che fosse una lotta continua. Eravamo quattro famiglie e ognuna di queste aveva una bella figlia o una moglie/madre bella ed erano tutte persone con cui intrattenevamo un rapporto di conoscenza ancora prima del confino. C’erano altre famiglie di militari con cui avevamo un rapporto di amicizia, ma i gruppi sono stati smistati in maniera studiata. Forse temevano che noi figli potessimo dar seguito al complotto dei padri? C’era molta invidia e non a caso ci sono state alcune spie tra i condannati. È stata una vita difficile, sia per la condivisione che per l’isolamento: raramente vi erano gesti di solidarietà. Quindi, noi esiliati non soffrivamo solo a causa della Sigurimi, ma anche per i reciproci comportamenti. In condizioni critiche la gente si comporta molto male. Lo spiega molto bene Dostoevskij in alcuni dei suoi libri, quando descrive l’atteggiamento delle persone che vivono sotto pressione, avendo subito egli stesso l’esperienza dell’esilio.
Parliamo del tuo divorzio politico. Tuo marito non se la sente di condividere una vita da confinati e abbandona te e il vostro bambino. Cosa hai provato?
Sono trascorsi quarantasette anni e mi ricordo ancora tutto alla perfezione. Io lo avevo sposato perché era intelligente, un diplomatico apprezzato, ma non ho mai provato un grande amore per lui. Lo avevo sposato più per sistemarmi, lo ammetto apertamente nel mio libro. Quando nacque il bambino, però, si creò una bella atmosfera in famiglia: stavamo bene. Un giorno, mentre si stava preparando per partire verso l’America per un impegno con l’ONU, gli confidai la funesta sensazione che provavo: “Succederà qualcosa di brutto a mio padre”, gli dissi. Lui mi rassicurò, dicendo che di generali ne avevano già arrestati tanti, non potevano certo arrestarli tutti. Le cose, invece, andarono proprio così: imprigionarono papà. Lui, non appena fu informato dell’accaduto, tornò in Albania su ordine del governo, andando direttamente dall’aeroporto alla riunione di partito. Tornò a casa l’indomani mattina e guardandolo, capii subito che aveva promesso loro, che avrebbe divorziato da me. In quel momento mi sentii profondamente offesa. Si stava comportando esattamente come gli altri, che sposavano ragazze privilegiate per poi lasciarle non appena i genitori cadevano in disgrazia. Ribadisco che non lo amavo, ma stavamo bene insieme. Vivevamo una buona esistenza sociale e intellettuale. La sua decisione mi ha molto offesa e mi ha provocato una sensazione bruttissima, che mi ha fatto odiare gli uomini. Per fortuna, quando mi sono recata in tribunale e ho spiegato ai giudici, (uomini e donne), la nostra storia, tutti si sono schierati dalla mia parte e nessuno dalla sua. Questo mi ha molto rincuorata, perché ho capito che non tutti erano con il partito.
Lo hai perdonato?
No, non l’ho perdonato, perché non ho mai compreso i motivi del suo egoismo, ma mi sono dimenticata di lui. Lavoravo sodo per un’azienda di produzione agraria, un lavoro pesante, difficile, che mi impegnava circa 14-15 ore al giorno, per cui non avevo tempo di pensare e ho dimenticato, così, tutto il mio passato. Ancora oggi, però, non mi capacito del fatto che in Albania tante mogli siano state abbandonate per motivi politici. Anche in altri paesi sono accadute cose similari, ma gli uomini non hanno lasciato le loro consorti. Chi ha preso questa decisione in Albania, lo ha fatto solo per proteggere se stesso e non certo per amore del partito. Come spiego brevemente nel libro, anche a noi è stata fatta la proposta di abbandonare nostro padre, con la promessa dell’abolizione del confino e il trasferimento in un piccolo paese, ma non abbiamo accettato! Non siamo caduti nella trappola della Sigurimi.
Ne La villa con due porte descrivi sapientemente i personaggi della tua famiglia: la figura di tuo padre, quella di tua madre, dei tuoi fratelli e soprattutto delle tue nonne, un capitolo quest’ultimo apprezzato da tanti.
Tutti dicono che il capitolo che narra delle due nonne è, forse, il più bello. Effettivamente, io sono cresciuta più con loro che con mia madre, che era una donna molto impegnata con il lavoro e il marito. Era un giudice, che durante la giornata non c’era mai e poi la sera si dedicava al consorte con cui usciva per delle passeggiate o per partecipare a qualche evento. Ho amato molto le mie nonne e forse è a loro che devo la mia passione per la scrittura. Erano buone e intelligenti. Quella paterna era tranquilla e di poche parole, tanto che per esprimere il suo pensiero, spesso, usava le sentenze. La materna, invece, era più vivace e ironica: io ero la sua preferita, mentre mio fratello grande era il prediletto della paterna. Sono state brave e pazienti con noi. Ancora oggi, quando mi sento un po’ giù, preparo il riso con il latte, una ricetta della nonna paterna, che mi fa sentire meglio e coccolata.
Oggi, tu non desideri più essere definita “la ragazza del Blocco”, ma vuoi essere menzionata per quello che hai realizzato nella vita. Ora, però, vorrei che facessimo un balzo indietro nel tempo e parlassimo della tua infanzia e adolescenza nel quartiere della nomenklatura. Che ricordi hai?
Il periodo più felice per me è stato quello universitario, che ho condiviso con i miei amici di università e quelli d’infanzia, studiando le materie che più amavo. Questo, per sottolineare che nel Blloku si viveva meglio che altrove, ma non bene, perché eravamo comunque privati della nostra libertà. Non ho mai amato quel quartiere che era una grande gabbia dorata, una sorta di grande fratello. Ricordo bene gli sguardi altrui pieni di rancore, perché ci consideravano dei privilegiati. Io sono nata nel Blocco, ma non ho mai avuto nulla da spartire con quel posto. Lo sguardo delle persone pieno d’odio l’ho ritrovato quando mio padre è caduto, solo che in quell’occasione ci ho visto cattiveria e soddisfazione.
Vera, per chiudere, facciamo un balzo nel tempo tutto in avanti. Come hai vissuto veramente dopo il confino e come stai oggi?
Non lo so. Le cose che ho voluto fare, ho fatto. Non mi ha reso felice dire tutta la verità. Vuoi sapere se sono contenta per quello che ho realizzato? No, non sono contenta di nulla. Ho fatto delle cose, ma voglio fare di più, voglio realizzare cose qualitativamente valide, desidero scrivere libri di qualità. Devo, però, ammettere di essere molto grata alla vita per le amicizie che mi ha dato, perché tante persone mi vogliono bene e mi apprezzano e io amo loro, ancora di più.
Leggi anche