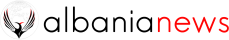Scrittore pluripremiato, lucido analista del metodo dittatoriale e del percorso socio-politico dell’Albania fino all’odierna democrazia, Fatos Lubonja è uno degli intellettuali dissidenti tra i più stimati, quanto dibattuti, dell’attuale panorama letterario e sociale albanese. Le sue idee e la consapevolezza delle brutalità dittatoriali gli sono costate diciassette anni di carcere. In questa lunga intervista, Lubonja racconta e accusa.
Sei figlio di Todi Lubonja e vivi la gioventù in una famiglia molto legata al regime. Nonostante questo, ti accorgi che qualcosa non va, che non è come viene detto, trasferendo queste perplessità nei tuoi scritti. Cosa avevi notato?
È una domanda che richiede una risposta corposa, in quanto dovrei parlare del processo. Quello che è accaduto, non è stato così improvviso e non è avvenuto a causa della condanna di mio padre, che fa parte di quel processo, anzi, rappresenta la sua conclusione. Ritengo di aver vissuto una sorta di percorso di consapevolezza, che mi ha fatto ben comprendere cosa fosse realmente il regime albanese. I miei ricordi partono dall’adolescenza, da quando ho iniziato il reale distacco dall’amore per Enver Hoxha, dal profondo attaccamento imposto al partito, per cui mio padre era membro del comitato centrale.
Qualcuno definisce tuo padre un liberale, nonostante fosse vicino al governo.
Al termine liberale si deve dare il giusto significato, secondo quello attribuitogli dal regime stesso. Mio padre era considerato un liberale, non certo nel senso ideologico del termine, come potrebbe intendersi oggi, in riferimento alla democrazia liberale, o al campo dell’economia. Questa è una parola usata spesso da Enver Hoxha per identificare chi aveva un atteggiamento più morbido, più aperto, più permissivo, nei confronti di quelle situazioni, verso le quali il regime si mostrava decisamente autoritario. Per esempio, mio padre fu condannato per aver autorizzato il passaggio in TV di canzoni italiane e straniere, come quelle dei Beatles, che fino a quel tempo non era permesso ascoltare. In questo senso era considerato liberale, come se si dicesse: “abbiamo più libertà di fare”. In realtà, la questione è ben più complessa, perché Todi ha fatto queste concessioni in un periodo in cui lo stesso Hoxha aveva dato segno di qualche apertura, che poi ha ritirato, rifugiandosi nuovamente nella chiusura e, ancora, oggi, non sono chiare le motivazioni di questo suo ripensamento. Probabilmente, il dittatore era influenzato da quanto accadeva in Occidente, dove imperversavano le proteste del famoso ’68.
Noi, in verità, non seguivamo quei fatti, ma a un certo punto subentrò uno scontro generazionale in Albania, tra i vecchi comunisti, i partigiani e noi della nuova generazione, che sentivamo la necessità di affermarci psicologicamente, di dire che esistevamo anche noi al mondo. Inoltre, guardavamo la televisione italiana e leggevamo libri, quindi, eravamo maggiormente in contatto con questo universo, più di altri. Effettivamente, costituivamo una fonte di pericolo per il potere, che, però, non poteva fare a meno di aprirsi, di concedere qualche spazio. Dopo la rottura con l’Unione Sovietica, c’è stata una pesante chiusura, che in qualche modo, doveva essere compensata. Il regime non avrebbe mai potuto sopravvivere nel totale isolamento, ma aveva comunque interesse a tenere tutto sotto controllo. Il concetto di liberale, quindi, era attribuito a chi tendeva ad aprirsi un po’ di più, specialmente verso l’Occidente. Nel 1972, Enver Hoxha tenne un importante discorso, a coronamento dell’incontro avuto con il rettore dell’Università, Agim Mero, a quel tempo amico di mio padre, che era stato segretario dell’Organizzazione della gioventù dopo di lui ed era poi, appunto, diventato rettore. Ricordo soltanto, che egli, in seguito, dichiarò Todi nemico del popolo. Durante questa riunione, organizzata ad hoc come sempre, il dittatore affermò che sarebbe stato meglio che i giovani albanesi, anziché seguire le radio e le televisioni straniere, avessero seguito quelle di stato e che, quindi, apprendessero le stesse informazioni dai media locali. Pertanto, volle aprirsi e sempre in quell’occasione, disse che sarebbe stato meglio che il direttore della Radio e della Televisione fosse stato Todi, perché era, appunto, più vicino ai ragazzi, quindi molto di più di Thanas Nano, per esempio, che invece era considerato un conservatore. A questo discorso ne seguì un altro, in cui elogiò i compagni partigiani, che avevano dato tanto al partito e al popolo albanese, ammettendo, però, di dover lasciare spazio alle nuove generazioni. Queste sue affermazioni non arrivavano a caso, perché, in qualche modo, erano il riflesso di un’atmosfera che aleggiava già tra la gioventù. Anche io ero tra loro e volevamo tutti un maggiore contatto con il mondo, la musica, i libri, l’arte. Avevo ventun’anni quando ha fatto questo discorso e già a mio padre, che era una persona, comunque, mentalmente aperta, arrivavano le prime conferme che la dittatura non fosse più un fatto di ideali, bensì di potere, un dominio che opprimeva, che chiudeva e che calpestava. Todi si interessava a tante cose, non trascurava le nuove idee e poi non gli mancava certo l’intelligenza di capire, che il mondo occidentale non era così arretrato come veniva descritto. Secondo il messaggio che passava attraverso il dittatore, era, invece, il mondo del male e tutto questo non gli tornava più. Io, anche, avevo diversi contatti tra gli intellettuali e poi avevo amici anche tra i perseguitati del regime, con i quali si parlava dei mali del comunismo, della sua genesi, dei crimini che aveva commesso e della sua necessità di tenere sempre il popolo in scacco. Noi volevamo seguire le mode, come tenere i capelli lunghi, ascoltare determinate canzoni, che non so perché ci piacevano, volevamo esprimerci in maniera differente. Ci imponevano di amare Enver Hoxha, non avevamo alcuna educazione sentimentale e tutto questo andava a sopperire le nostre mancanze. Per noi, le canzoni di quel tempo, quelle di Celentano, di Mina, di Battisti erano una scappatoia alla repressione; io, per esempio, le conoscevo a memoria. E così procedeva la nostra duplice vita, fatta, da una parte, di conformismo verso gli slogan imposti dal regime e dall’altra di un’apertura verso l’Occidente. E poi non mancavano le letture, come il Diario di Che Guevara, che a quel tempo in Albania, certo non era ben accetto. Per me c’è stato un duplice processo di consapevolezza, da una parte quello intellettuale, attraverso i libri, la televisione e l’altro dato dal duro scontro con la realtà, che mi ha fatto capire come stavano le cose in maniera evidente. Con questa raggiunta consapevolezza ho iniziato a tenere i miei diari. Il toccare con mano la realtà, mi ha spinto, ulteriormente, verso la più cruda delle verità.
Dopo l’arresto di tuo padre, perquisiscono la casa e trovano gli scritti, giusto?
Non è andata così. Noi siamo stati arrestati in quattro. Il primo a essere fermato è stato mio zio e i miei diari erano in casa sua, dove erano nascoste, anche, le cose di mio padre. Egli possedeva armi e trofei di guerra, quindi hanno trovato tutto. Todi mandò i diari a casa sua per stare più tranquillo, ma mio zio, che era un donnaiolo, aveva un’amante, alla quale confidò questo segreto. La donna lo riferì a suo cugino appartenente alla Sigurimi. Mio zio divenne uno degli spiati e fu arrestato con suo cognato. In seguito, incarcerarono me e mio padre.
Sei stato, quindi, imprigionato con l’accusa di propaganda contro il regime…
In realtà, non era propaganda, quella era un’accusa pre-confezionata. Tra i miei scritti c’era anche un romanzo, che io ho definito anti-romanzo, con la mentalità del giovane che voleva distinguersi, che voleva essere diverso. Trovarono questo componimento e i diari dell’Università e li sequestrarono per il tribunale. Non li ho più ritrovati e ancora oggi li cerco disperatamente.
Hai ricevuto una prima condanna a sette anni, poi una seconda a ben sedici anni. Perché punirti una seconda volta? Facevi così paura?
Non avevano paura di me. Semplicemente, attuarono una pratica molto diffusa in Albania a partire dagli anni ’70, chiamata la “ricondanna”. In poche parole, infliggevano una nuova condanna a quei prigionieri considerati pericolosi. Un metodo assurdo, se si pensa che un carcerato si ritrova rinchiuso ai fini di cautelare la società e non essere, quindi, un soggetto pericoloso. In realtà, era una modalità speculare dell’atmosfera creata dopo gli anni ’60, caratterizzata da uno spirito fortemente impietoso verso gli altri. Il regime non doveva mostrare alcuna debolezza verso i nemici, doveva essere duro fino in fondo. Questo era lo stalinismo di Hoxha: non dover cedere mai. Il suo era, in realtà, un atteggiamento fondamentalmente dettato dall’insicurezza, data dai tanti crimini commessi. Per questo, era solito ordinare purghe, come quella in cui è stato coinvolto mio padre o la famosa purga dei generali, oppure la condanna degli economisti. Avvenimenti significativi, quindi, che sono avvenuti nell’arco di tre o quattro anni: parliamo del periodo che va dal ‘73 al ‘76, grosso modo. Nel ‘77 le purghe cessarono e in tal senso, certo che si può parlare di potere paranoico. La mia esperienza è stata particolarmente sfortunata, non tanto per me, quanto per i miei due amici che furono entrambi fucilati. A tal proposito, ho scritto un libro sulla mia seconda condanna, pubblicato in inglese, che si intitola La ricondanna.
Due miei amici, che avevano studiato nell’Unione sovietica, ex comunisti, scrissero una lettera dura contro Enver Hoxha e il comitato centrale: era il 1977. Una missiva scritta dal carcere, non aperta, ma indirizzata al comitato centrale, sicuramente accusatoria, ma, infondo, solo una lettera da parte di due persone. Il governo non si accontentò di condannarli, come in media faceva, cioè per propaganda contro il regime, ma volle dar loro una punizione esemplare, fabbricando un’accusa che li vedeva fondatori di un’organizzazione criminale e tra i membri, ci finii anche io. Quindi, ci massacrarono in un processo investigativo per far accettare questi fatti, in realtà, inesistenti e poi a porte chiuse, con un procedimento di secondo grado, senza diritto di appello, senza avvocati, nella prigione di Tirana. I miei amici furono condannati a morte e io ad altri sedici anni di carcere. Per terrorizzarci, ci fecero vedere le foto dei loro corpi dopo la fucilazione.
Non ti chiederò nulla sulla tua prigionia, perché so che è stata un’esperienza molto sofferta.
Io scrivo sempre sulla mia vita carceraria, non mi spaventa, è un modo per darle un senso. Non voglio che questi diciassette anni siano considerati persi. Ho contribuito a una pubblicazione intitolata Nostalgia. Saggi sul rimpianto del comunismo (Bruno Mondadori, 2010), scrivendo un saggio intitolato Nostalgia e dolore, in cui parlo, appunto, della prigionia.
A un certo punto, finisci in cella d’isolamento. Perché?
In carcere, come in tutte le prigioni, c’erano le celle di punizione e non era difficile finirvi. Ti potevano trasferire per diverse ragioni. Per esempio, io fui punito in questo modo, perché dopo la seconda condanna, non accettai più di lavorare. Potevi finirci anche se non lavoravi un solo giorno. Inizialmente, accettai il lavoro con la speranza di poter essere liberato, ma dopo la ricondanna no, dopo mi sembrò inutile. Presi una decisione difficile, che pagai cara, ma che mi portò dei benefici, perché lavorare nelle miniere, con tre turni, notte compresa, era più duro del carcere stesso.
Parliamo delle tue pubblicazioni italiane, Diario di un intellettuale in un gulag albanese (Marco Editore, 1994) e Intervista sull’Albania. Dalle carceri di Enver Hoxha al liberismo selvaggio (Il Ponte Editrice, 2004). Tu sei, oggi, conosciuto come uno dei più lucidi analisti della politica del regime e dell’attuale democrazia albanese. In questi libri, racconti, ma accusi anche, chi ha sostenuto, a tuo parere, se pur sommessamente, il totalitarismo, uno su tutti, come tu dici, Ismail Kadare. Ti rivolti contro chi ha sostenuto il potere, perché costretto e sostieni che non sia il caso di dare troppa visibilità a quegli intellettuali che si sono girati dall’altra parte, perché non hanno avuto scelta. Mi interessa il tuo parere su questo, cristallino, come sempre.
Cito, a tal proposito, il filosofo tedesco Karl Jaspers, vissuto nella Germania nazista. In un suo famoso discorso, egli parla di quattro responsabilità importanti da analizzare. La prima è la responsabilità legale, quindi di chi ha infranto le leggi, di chi ha commesso crimini, come il processo che noi abbiamo subito. La seconda è la responsabilità politica di chi ha, appunto, politicamente appoggiato il regime. La terza è quella morale, appartenente a tutti coloro che hanno affermato di non aver potuto fare altrimenti, perché costretti a eseguire gli ordini e ultima la responsabilità metafisica, che dovremmo sentire tutti noi, per non aver fatto abbastanza. Anche io, volendo, con la mia paura, ho spinto i vagoni e dato una mano al regime, per esempio. Queste quattro responsabilità sono state fondamentali e di supporto indiretto al totalitarismo albanese. Parlando di Ismail Kadare, posso non attribuirgli solo la responsabilità legale, ma quella politica, la morale e la metafisica, gliele attribuisco tutte, perché egli, come altri, ha appoggiato anche politicamente la dittatura, tramite la sua opera. Kadare e appunto, altri, sono stati la voce e gli occhi del regime, basato sull’ideologia del potere, che può essere definita nazional-comunismo e nazional-stalinismo. In altre parole, la dittatura era un frutto del sincretismo di queste due dottrine. L’orgoglio nazionale, per dire, era usato politicamente per isolare l’Albania, vantandosi di una gloria del passato come metafora della Resistenza del Paese verso l’Imperialismo e il Socialitarismo. Basti leggere Tamburi della pioggia di Kadare, ispirato alla Resistenza albanese, come orgoglio nazionale usato dal potere, per poi opprimere l’individuo e al comunismo come la promessa di un futuro inesistente. Per dare un’idea sul sincretismo di entrambe le ideologie, posso fare riferimento a quando Hoxha ha abolito le religioni. Per un periodo, la religione degli albanesi è stata l’albanità e parallelamente a questo concetto, correva l’idea della storia come continuità di un popolo e della sua identità. In Albania c’è sempre stata una concezione essenzialista dell’individualità popolare, passata, anche, in questa nostra generazione. In verità, a oggi nulla è cambiato. L’albanità degli albanesi è la stessa dai tempi degli illiri, come se l’identità fosse la stessa. In realtà l’identità è un processo di trasformazione, ma in Albania è stata creata più che altro sui simboli. Quella degli albanesi è creata, costruita. Tornando all’abolizione delle religioni, Hoxha proibì di volgere lo sguardo a esse, sostenendo che gli albanesi non erano mai stati religiosi è che la loro religione era l’albanità. Questo, in qualche modo, è il social stalinismo o nazionalismo, come dir si voglia. Gli intellettuali, secondo me, hanno nutrito questa ideologia del potere e soprattutto Kadare con i suoi scritti, che io leggo come la più riuscita illustrazione letteraria dell’ideologia del potere. Un po’ da tutti i suoi libri si evince questo, anche quello che io chiamo auto-orientalismo albanese, che è la fuga dall’identità ottomana. L’ultimo numero della mia rivista albanese Perpjekja si intitola Gli albanesi durante il periodo ottomano, in cui cerco, appunto, di decostruire il mito dell’oscurantismo turco, che avrebbe portato la disgrazia sul periodo glorioso d’Albania. Questi sono i miti che cerco di sfatare. Tornando agli intellettuali e alla responsabilità metafisica, con loro non si può nemmeno discutere; oggi, si vantano di aver fatto resistenza al regime, che sono stati liberi tutti e questo è un modo di pensare che purtroppo continua in Albania. Io ho contestato Kadare anche per il modello che è stato agli occhi degli altri; è come se avesse voluto dare l’idea che se vuoi diventare famoso, devi servire il potere e non essere un intellettuale alla ricerca della verità.
L’Albania, ce la farà a uscire dal suo Purgatorio?
Io credo che nessuno sia in Paradiso, e che tutto questo mondo sia in Purgatorio. Da tempo ho smesso di parlare di transizione dell’Albania; in tanti hanno dato una connotazione biblica al percorso del Paese, ma io ho smesso di pensarla in questo modo. Il mito della transizione è stato creato attraverso due autori di successo degli anni ‘90, il famoso Francis Fukayama, il narratore della fine della Storia, che vede l’Occidente ben riuscito e vincitore e Samuel P. Hantignton, che nel suo libro Lo scontro delle civiltà e il suo ordine mondiale, esprime un concetto molto interessante per i Paesi come il nostro. Egli parla della Turchia, che rispecchia , comunque, la situazione dell’Albania: in poche parole, Paesi come il nostro avrebbero un élite che guarda all’Occidente culturalmente, con una popolazione orientale e quindi il compito di questa élite, sarebbe quello di portare la popolazione verso la sponda occidentale, proprio come Mosè ha fatto con gli ebrei, portandoli verso la Terra Promessa. L’esperienza mi ha insegnato che non serve dare una connotazione biblica al cammino albanese; aggiungo che all’inizio ci ho creduto anche io, tanto che nella mia rivista si possono trovare interi articoli dedicati alla transitologia, ma non ci credo più. Infondo, anche l’Occidente non è arrivato alla meta, ma sta percorrendo la sua strada. Io parlo di una direzione sbagliata del percorso dell’Albania, che è una conseguenza della direzione errata del cammino occidentale. Quindi, la nostra nazione non è solo ostaggio del proprio passato, ma anche dell’Occidente, di cui ha la stessa malattia, ma è sprovvista anticorpi per poterla contrastare, almeno questo è il mio punto di vista. La patologia è data dal neoliberismo e da quella globalizzazione che ha creato il sistema in cui è finita la maratona iniziata dalla rivoluzione industriale inglese; oggi, l’evoluzione è incentrata sull’homo oeconomicus, figura regnante e creatrice dei politici manager dell’economia. Con questo egocentrismo feroce del liberismo e del neoliberismo, fortemente in crisi, l’Albania è l’espressione peggiore dell’individualismo estremo, dove i politici sono manager dell’economia, in un Paese dove l’economia è criminale, appartenente alla droga. Ecco perché, dico che il nostro Paese sta andando verso una direzione sbagliata, seguendo un l’ideologia dominante, europea e occidentale. Quindi, la malattia occidentale, che si manifesta in Albania nella maniera peggiore non avendo quest’ultima gli anticorpi per sconfiggerla, è il post democrazia, una patologia che sta subendo, in qualche modo, anche l’Occidente, proprio perché non è il popolo che decide, ma sono gli oligarchi, i ricchi. L’Albania è passata dalla dittatura alla post democrazia, senza avere una democrazia in mezzo, cosa che invece l’Occidente ha avuto e quindi ha più anticorpi. In questo senso, non è Purgatorio, ma facendo il catastrofista, dico che l’Albania sta andando verso l’Inferno. Cosa succede nella nostra nazione, che è diventata un Paese che produce criminali? Nessuno vede nulla. Quando leggo il libro di Nicola Gratteri, Patrigni e Padroni. Come la ‘ndrangheta è diventata classe dirigente è come se io leggessi la storia dell’Albania.