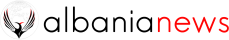L’emigrazione dai paesi del Mezzogiorno d’Italia di antico insediamento etnico (a partire dal secolo XV dopo la scomparsa di Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe di ogni tempo e paese) è legata strutturalmente al grande esodo di milioni di italiani, dopo i due conflitti mondiali, diretta verso le Americhe, quella del Nord, specialmente New York) e quella del Sud (per lo più a Buenos Aires).Nell’ultimo trentennio una piccola parte verso il nuovissimo continente (l’Australia) mentre un nucleo consistente si diresse verso l’Europa Centrale soprattutto Germania, Gran Bretagna (a Liverpool, Croydon, Oxford, Herit, Wallington, Edinburgh, Brighton dove si stampa tuttora “Albanian Life”), Belgio, Confederazione Elvetica ed altre nazioni. In questi Paesi gli albanofoni, tantissimi lucani, hanno dato vita, partecipandovi attivamente, a focolari etnici (in Alb.= Vatre), circoli, società, sodalizi di beneficenza, comunità, assieme ai fratelli della “diaspora” provenienti da Sicilia, Calabria, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania.
Negli U.
S. A – Merka e ftohte
La maggioranza degli immigrati, di etnìa originaria arbëreshe, è concentrata a New York e nel New Jersey, minoranze etniche anche nell’hinterland di Detroit, a San Francisco, a Waterbury (Connecticut) dove hanno costituito aggregazioni proprie (come la N.
I.
A.
F. la più grande e rappresentativa), con vari clubs e mantenendo, nel contempo, legami epistolari, scambi di beni di consumo e abbigliamento, con i “katund” di provenienza; già un centinaio nel secolo scorso, oggi una sessantina oltre alle grandi comunità extra-moenia, fra cui (in Italia) Palermo, Bari, Roma, Cosenza e la stessa Potenza (in base ad una statistica B.
C.
A. degli anni ’8O è forte di circa quattromila albanofoni delle varie aree meridionali).Una gazzetta intitolata “Illyria” che si stampa nel Bronx è sede coagulante di Arbëreshe lucani e meridionali oltre che Kossovari. Numerose le Società Benevolenti fra cui Lavello, con il noto Social Center di New York, i clubs dei trecchinesi, rioneresi, degli immigrati di Montalbano Jonico e Irsina, di Melfi e Venosa, di Ginestra e Montescaglioso, e della estesa famiglia della “nazione aviglianese” oltre alla comunità di Chicago e della stessa Boston (ivi viene stampato il quotidiano “Dielli”, il più antico foglio della diaspora in emigrazione).Varie le occasioni aggreganti (dalle feste patronali di San Rocco e della Madonna di Costantinopoli, del Carmine e di San Biagio, di San Gianuario e Sant’Elia, San Donato e San Giustino de’ Jacobis ecc.) per promuovere, con generosità e solerzia, raccolte di fondi (i dollari per placare i dolori e le angustie dell’esistenza rurale, per ricostruire la chiesetta di San Nicola flagellata dai terremoti o per venire incontro alle famiglie colpite, a volte letalmente, dalle varie epidemie; per sostenere l’agricoltura dei nostri paesi mortificata dalle tante peronospore, malattie vecchie e nuove della vite e dell’olivo, piante essenziali dell’economia delle aree interne della montagna potentina e dei calanchi del Materano, fra Ferrandina, Teana, Aliano ed i tanti paesi-presepe della regione). Negli ultimi tempi il nuovo fenomeno (in particolare dell’estate 1990-1991) dei cosiddetti “boat-people” si è verificato, infatti, nei nostri paesi arbëreshe del Sarmento (San Paolo e San Costantino Albanese) e nel comprensorio del Vulture (da Maschito, Ginestra a Barile, ma anche da Venosa, Rionero) con un innesto di nuovi profughi e di famiglie skipetare negli spopolati paesi lucani, falcidiati all’emigrazione di braccia, prima, ed ora anche di intelligenze verso il nord Italia e l’estero. Nuova linfa, dunque, con i pregi ed i difetti di un’ondata immigratoria di massa, all’Albania, dal Kossovo, dalla Macedonia.
In America Latina – Merka e Ngrohte
Di notevole rilevanza risulta, oggi, la comunità arbëreshe di Buenos Aires (piccoli nuclei sono anche a Bosques, Temperley, Mar del Plata, Rosario, a “Ginestrella” costituita da immigrati, di varie generazioni, provenienti dal Vulture e particolarmente da Ginestra) e nella vicina Montevideo (Uruguay). Quella di Buenos Aires è la più grande e solida comunità albanofona dell’intero continente sudamericano: 25mila sono gli Arbëreshe, riuniti in associazioni, cenacoli, organi dirigenti, federazioni di emigrati, società sportive e comitati di feste popolari e serate danzanti. Sono per lo più meridionali, delle sette regioni che ospitano comunità alloglotte, e coltivano buoni e crescenti rapporti con le istituzioni pubbliche e le Regioni della madre-patria e con la stessa sede dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania a Buenos Aires. In Venezuela, a far data dagli anni 50, “la piccola Venezia” e Caracas, Bolivar, Puerto La Cruz, Maracaibo, diventano punto di attrazione, in termini di lavoro e ricchezza, dell’emigrazione lucana. Infatti, degli oltre settemila nostri corregionali, moltissimi aderiscono ai centri culturali italo-venezuelani ed alle associazioni ricreative dei lucani. Un’aliquota non marginale (almeno il 5%) è formata da famiglie arbëreshe di terza generazione di Ginestra e Barile oltre che di Brindisi di Montagna, San Paolo Albanese e Napoli.
In Australia
Nelle grandi metropoli moderne (il governo dell’isola ha festeggiato da poco i duecento anni di costituzione) di Sidney, Melbourne, Adelaide, nella contigua isoletta di Tasmania (la città capoluogo è Obart) i molti rifugiati dall’Albania dell’ultimo ventennio hanno organizzato una fiorente ed operosa comunità, a cui si sono aggregate nuove generazioni di arbëreshe (dall’Italia) e di kossovari, epiroti, montenegrini (ex Jugoslavia). Hanno rapporti sia con la Chiesa cattolica che con quella bizantina ed ortodossa dei paesi di provenienza. Anche qui un foglio locale, pubblicato ad Adelaide, ed intitolato “Shqiperia” testimonia il bisogno antropologico di presenza e identità di una lingua, una cultura, di remoto ceppo indo-europeo, di cui Nermin Vlora, studiosa di lingue antiche, si è servita per decifrare, prodigiosamente, iscrizioni su pietra in lingua etrusca. Sul tema, lo stesso etruscologo di fama mondiale Massimo Pallottino, ha posto attenzione ed interesse scientifico.
 Costume festivo di donna albanese. Foto Santino Amedeo, Grosseto
Costume festivo di donna albanese. Foto Santino Amedeo, GrossetoIn Grecia
Nel distretto dell’Epiro ai confini con l’Albania meridionale e nel Peloponneso interno, specialmente a Koropi, Maratona, Spata, i cittadini arvanidhi che hanno le stesse qualità morali che affratellano gli Arbëreshe in Italia: rispetto sacro dell’ospitalità, cordialità, semplicità, gelosa custodia delle proprie variegate tradizioni e dei policromi costumi nella ritualità bizantina e ortodossa. La lingua ci unisce, è il nostro comune denominatore. Per la cronaca sono tanti gli etimi ed i toponimi ancora in uso nelle parlate arbëreshe d’Italia (dalla Basilicata alla Sicilia) di schietta ed inequivocabile derivazione greca. La lingua ci dà la possibilità di comprenderci, come tra fratelli di una sola grande famiglia etnica. Tutti abbiamo il dovere-diritto di renderla più compiuta e trasmissibile attraverso i moderni strumenti didattici e le tecnologie informatiche, per superare il gap di una cultura, di una paremiologìa, di una letteratura per secoli, almeno cinque, tramandata oralmente (come ribadisce nel progetto in itinere Irrsae-Basilicata, il noto prof. Tullio De Mauro, docente di Filosofia dei Linguaggi all’Università di Roma, da anni studioso e generoso sostenitore delle “lingue tagliate” in Italia (con Sergio Salvi). Ma quale obiettivo (e con quali strumenti) si pone ora la Repubblica d’Albania per rendere meno labile e provvisorio il “link” di storia e lingua arcaica che ci accomuna da mezzo millennio? Un quesìto, almeno per adesso e nella forma compiuta, senza adeguata risposta. Gli albanofoni, circa 10 milioni compresi coloro che hanno origini albanesi “tout court”, vivono ed operano sparsi in ogni parte del pianeta. Come tutti i popoli oppressi – ci confessa il sen. Donato Scutari, già sindaco di San Costantino Albanese e da sempre tenace propugnatore della cultura e delle tradizioni arbëreshe- gli Albanesi vengono definiti “esuli erranti” (quasi in parallelo con la martoriata cultura ebraica) e perfino in Crimea ed in Alaska sono registrate presenze di aggregati albanesi da punti diversi dei Balcani. La difesa delle lingue e culture – meno – diffuse (secondo la recentissima terminologia UE, fatta propria dall’European Bureau for Lesser – Used Languages di Dublino – Eire e dallo stesso Comitato nazionale federativo, Confemili, con sede a Roma) è un arricchimento del mosaico culturale dell’Europa prossima ventura, da costruirsi non solo in termini di monete/a, bensì nel rispetto delle singole peculiarità etnico – linguistiche delle cinquanta e passa “isole” storico-culturali alloglotte del vecchio continente. La sensibilità dei governanti ai vari livelli deve uniformarsi, nel prosieguo di un rivoluzionario processo di unità dell’Europa, alla Convenzione-Quadro approvata già da vari Stati, fra cui l’Italia, e spingere a superare le inerzie residue verso la comprensione rinnovata di una dimensione inter-etnica, solidale e tollerante nella pace per tutti i popoli.
Francia
Nel vasto hinterland di Parigi (ove l’omonima associazione culturale pubblica, da tanti anni, il foglio “Koha Jone” – Il nostro tempo – che si avvale, fra gli altri, dei contributi creativi di Ismail Kadare già nella rosa del premio Nobel per la letteratura, ivi da una diecina d’anni in esilio) e di Antoine Musacchio discendente della nobile famiglia di Berat, ma anche a nord ed a sud della Francia (da Vichy, Saint Raphael, Frejus a Saint Julien Les Metz, Bellevue, Nîmes, Lille) nuclei di Arbëreshe operano, insediati da almeno una generazione, raggiungendo anche lusinghieri livelli di status in aziende locali, istituti scolastici, alberghi.
Germania
Dall’accogliente ed industriosa Stoccarda ai centri urbani di Sindelfingen, Amburgo e nella cintura carbonifera tedesca, migliaia di albanofoni lucani hanno, con impegno e dedizione, contribuito alla formazione del reddito nazionale da alcuni decenni prima della caduta del muro di Berlino (1989). Fraternizzando hanno ricostruito, in terra straniera, gli orgogliosi focolari della loro identità etnica mai sopita, in particolare da San Costantino Albanese e Maschito.
Belgio
Da Neuchatel a Charleroi, da Beringen all’europea Bruxelles, sin da almeno due generazioni, in fabbriche, miniere ed altre attività locali, aggregazioni non piccole provengono da Maschito, Ginestra e Barile. Si distinguono, inoltre, dandosi appuntamento in occasione di festività patronali e ricorrenze storiche, nell’ambito della ristorazione, fastfood e del management alberghiero.
Svizzera
A latere delle iniziative della dinamica ed accreditata “Casa d’Italia, sez. Lucana” di Berna e Zurigo, aggregazioni di famiglie arbëreshe (nel campo dell’artigianato e dell’orologeria, delle produzioni alimentari tipiche) sono attive da vari decenni. Anche a Butschwill, Bassersdorf, Basilea, Diessenhofen, Effretikon, Betteach, si registrano numerosi insediamenti alloglotti provenienti da San Paolo Albanese e Ginestra.
Canada
All’ombra delle grandi antenne paraboliche di ChinRadio che trasmette programmi in ben 31 lingue del mondo (manager editoriale il “lucanissimo” Johnny Lombardi, originario di Pisticci) a Toronto ma pure a Montreal, (nell’ambito di Basilucania) e numerosi a Port Heady, Mississauga, Downsview, le famiglie arbëreshe hanno contribuito a fare grande il Paese della bandiera a foglia d’acero.
Bibliografia
ChinRadio – A multilingual & Multicultural Broadcasting, 622 College Street, Toronto (Ontario) Canada;Dielli – The oldest Albanian Newspaper in the world (in english and albanian), Boston, Mass, USA;Radio Tirana – Fax – Ass. Mediterranea, Presidente Gaetano Grillo, Milano;Schirone M. “Quelli dal volto bruno (I lucani nel mondo)”, Pianeta Libro ed., (2 voll.) 1998;Albanian Life, Monthly magazine, editor R. Hibbert, Brighton (Great Britain).
Glossa etnica minima
Arberia: territorio “ideale” che raggruppa le “vatre” di tutte le comunità albanofone sparse nel mondo.
Arbëreshe: sono i cittadini di origine albanese insediati nelle comunità etniche delle regioni meridionali dell’Italia, dal secolo XV in avanti.
Arberori: sono i locutori albanesi delle altre Nazioni dell’Est (Romania, Ungheria, ecc.) tradizionalmente estranee al territorio storico.
Arvanidhi: i cittadini di origine e lingua albanese della Grecia che non riconosce, ancora, l’esistenza di culture e lingue diverse da quella ufficiale nell’Ellade.
Shqiperia: la “Terra delle Aquile” è l’odierna Albania.
Shqipetar: i cittadini di nazionalità albanese residenti nella Repubblica con capitale Tirana.
Kossovari: i cittadini (dell’ex Jugoslavia) con lingua madre albanese insegnata all’Università di Prishtina, facevano parte della “Grande Albania”.
 Nota sull’Autore:
Nota sull’Autore:
Donato Michele Mazzeo (Barile, 1947) laureato in Lingue e Letterature Straniere, abilitato all’insegnamento di Lingua e Civiltà Inglese negli istituti Superiori, iscritto all’Ordine Nazionale Giornalisti e Pubblicisti di Roma, già collaboratore di quotidiani e vari periodici, è attualmente redattore esterno della Rivista `Basilicata Regione/Notizie’; Direttore responsabile-Fondatore di “Basilicata Arbéreshe” e dei quaderni.
Consulente della CIFE del Provveditorato agli Studi di Potenza, collabora alla rivista di aggiornamento sperimentazione didattica “Il Nodo”.È borsista Study-Visits e referente per la Basilicata del Co.
N.
Fe.
Mi.
Li., Roma, aderente all’E.
B.
L.U.
L. (European Bureau for Lesser-Used Languages), membro Direttivo della F.
E.
M.
P. sede a Cannes (Francia).
Fra i titoli di volumi pubblicati: Etnografia e Albanesità (Potenza, 1987), Kroj Arrévet – Albania di Basilicata (Rionero, 1985), Ishi nje here (Lavello, 1990), Due Francesi ad Acerenza (Lavello, 1995), Michele Granata fra i Martiri Lucani della Repubblica Napoletana del 1799 (Lavello, 1998).